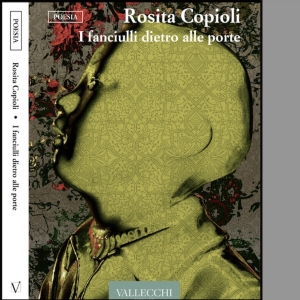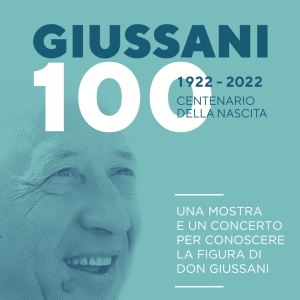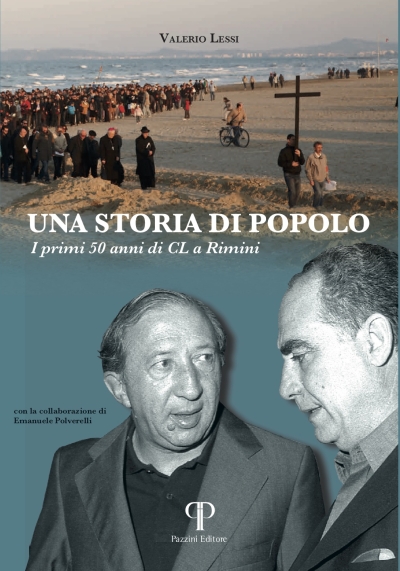[Storie] Ricominciare si può. Intervista a don Burgio, cappellano nel carcere minorile di Milano
«Non esistono ragazzi cattivi». La scritta campeggia all’ingresso della Comunità Kayros, ed è ripresa dal titolo del libro del suo fondatore, don Claudio Burgio, da diciassette anni cappellano al carcere minorile Beccaria di Milano. «L’idea che esprime questo slogan - spiega a BuongiornoRimini - è che la cattiveria non è innata nelle persone, tantomeno nei ragazzi che incontriamo. La cattiveria è una maschera, con cui questi ragazzi cercano di nascondere le proprie fragilità, le proprie debolezze, le proprie storie difficili. Però quando ritrovano l’impronta originaria che c’è in loro, la vita cambia, diventa molto più attrattiva».
Don Claudio Burgio sarà mercoledì 26 aprile al Teatro Galli di Rimini, ospite dell’incontro organizzato dal centro culturale Il Portico del Vasaio. Insieme a Fiammetta Borsellino, figlia del magistrato ucciso dalla mafia, e a Roberto Di Bella, presidente del Tribunale dei Minori di Catania, dialogherà sul tema Una giustizia che ricrea. Vittima o colpevole, cosa permette all’uomo di ricominciare?
Senta Burgio, ma dire che i ragazzi non sono cattivi non è buonismo, il solito modo di negare le responsabilità personali e di attribuire ogni colpa all’ambiente, alla società?
È un’obiezione che spesso sento dire. In genere è sulla bocca di chi ha un senso di giustizialismo molto forte. Per me la giustizia non ha a che fare con la vendetta, con la retribuzione. Noi crediamo molto nella giustizia riparativa che vuol dire, contro a ogni buonismo, che i fatti vanno riconosciuti, che i reati vanno condannati. Però ciò non significa che la persona non possa cambiare, che non possa riconciliarsi, anche con le vittime, che non possa fare un cammino di cambiamento. Noi lavoriamo per questo, sosteniamo questo tipo di speranza. Il buonismo lo consideriamo una forma di violenza, non è certo un modo per educare i ragazzi. Non sarebbe serio omettere le loro responsabilità. Crediamo però che ogni ragazzo non coincide con il proprio male, con le proprie azioni malvage. C’è sempre la possibilità di una redenzione, di un cammino.
C’è sempre la possibilità di ricominciare, lei dice. Alcuni seguono un percorso di recupero ma poi ricascano nella violenza, nella delinquenza. E con questi cosa fa?
C’è chi cambia al primo colpo, ci sono molti ragazzi che attraverso vari itinerari di giustizia riparativa, di messa alla prova, cambiano subito, capiscono il disvalore di certe azioni. Ci sono altri che fanno fatica a cambiare subito, hanno bisogno di più momenti. Quindi una ricaduta non significa che un ragazzo non possa crescere, non possa riabilitarsi. Vuol dire he ha bisogno di qualche input in più.
Nella sua comunità i cancelli sono sempre aperti. L’ educazione è dunque un rischio che rispetta la libertà?
Sì, non abbiamo l’idea che la legge, le regole siano sufficienti a cambiare un ragazzo, a renderlo più consapevole. Servono le regole, ma ci vuole anche una presa in carico della libertà di questi ragazzi. Finché non arrivano a interiorizzare la regola, finché non arrivano a prendere coscienza della loro vita, non riusciranno a cambiare. La libertà è quello spazio, quel margine che permette a questi ragazzi di interiorizzare, di entrare dentro una scelta, una decisione. Tenere i cancelli aperti giorno e notte è una sfida, un modo per dire a questi ragazzi: questo non è un carcere, qui c’è di mezzo la tua coscienza, la tua libertà, scegli e decidi se rimanerci o no.
Il rapper Baby gang ha detto di lei: lui guarda la persona non le carte. Ha capito bene il suo metodo?
Certo, lui non sa cosa siano le carte perché non ha mai avuto un’educazione alla legalità. Per lui lo Stato con le sue leggi è qualcosa di sconosciuto. Per affrontare questi ragazzi bisogna saper anche interagire, guardare negli occhi, sospendere il giudizio, provare ad aiutarli nella fiducia. Molti nostri ragazzi non conoscono e non riconoscono l’autorità perché ritengono il mondo adulto, il mondo delle istituzioni, come irrilevante. Quindi bisogna aiutarli a comprendere che si parte da un rapporto umano, da una fiducia, da un ascolto, guardando la persona per quello che è, non solo per quello che fa.
Di cosa hanno bisogno questi ragazzi, al fondo?
Hanno bisogno di adulti credibili, hanno bisogno di avere un rapporto serio con persone che sappiano in qualche modo incuriosire la loro coscienza. Sappiano anche farla nascere, in alcuni casi. Hanno bisogno di adulti vicini credibili, che tendenzialmente siano coerenti, e non adulti che diventano come amici: questo è il vero dramma, una età adulta che si è liquefatta, non ha più autorevolezza, non sa più essere diversa dalla generazione dei figli.
Hanno bisogno di un padre?
Spesso sì, magari c’è il padre ma è assente, insignificante. I ragazzi cercano una paternità di altro tipo, che abbia a che fare con la testimonianza di una vita credibile. Qualche anno fa i ragazzi mi hanno regalato un quadretto per la festa del papà. Accanto alle foto hanno inserito questa frase: non ci hai mai detto come vivere, ti sei i lasciato guardare e noi abbiamo capito. Quindi non sono sufficienti le parole, tanti paternalismi. Tanto maternage non serve, hanno bisogno di vedere persone convinte dalla vita.
Come si fa a vedere una possibilità positiva in chi le ha combinate tutte?
Anche guardando alla storia propria, e a quella dell’umanità. Sono cristiano e scopro nel Vangelo che anche Gesù è stato messo in croce e quindi è stato vittima di un’ingiustizia clamorosa. E quindi da quella croce, da quell’ingiustizia è nato qualcosa di grande, è nata una resurrezione, è nata una possibilità nuova. Soprattutto guardando al Vangelo riesco a capire questo dinamismo. Però qualcuno anche laicamente può capire che non tutto finisce a quindici sedici anni. Quanti cammini di liberazione ho potuto vedere in carcere! Basterebbero questi per convincere che è possibile.
Come devono porsi gli adulti davanti ai ragazzi ‘cattivi’? Può essere un alunno a scuola, un vicino di casa, un amico del figlio o magari un figlio…
Bisogna incontrare questi ragazzi senza averne paura, senza avere pregiudizi. Bisogna sapere che arrivano da storie drammatiche, in cui il bullismo è la reazione a qualcosa che hanno subito in precedenza. Sono ragazzi molto fragili, bisogna saperli prendere. Loro tendono a nascondere la debolezza, ma sono ragazzi che spesso mi raccontano che hanno subito violenze; quindi, sono stati vittime di bullismo nell’infanzia. Occorre affiancare, accompagnare, camminare con questi ragazzi fino a quella confidenza, a quella fiducia che permette loro di verbalizzare le proprie emozioni , le proprie rabbie.
Cosa è cambiato nella sua vita dopo aver varcato i cancelli del Beccaria?
Un ministero più gioioso, meno convenzionale, meno abituato a certi riti scontati che si ripetono. Un ministero molto vivo perché ogni giorno sono chiamato a capire se questo Vangelo è reale o no, se regge l’urto anche del male. Questo apre molte domande, mi ha portato a vivere con più realismo la mia fede.
Valerio Lessi
Banca Popolare Valconca, lacrime di coccodrillo
Il titolo di questo editoriale è fin troppo facile, non sono certo che l'editor in chief non lo modifichi; ma qualunque sia la scelta, il requiem sulla tomba della Banca Popolare Valconca è già stato suonato, con buona pace (appunto) dei vari soggetti che hanno inseguito non un sogno -i sogni meritano di essere pensati da qualcuno che ha idee, realismo e competenze- ma un'utopia velleitaria e confusa, nel segno di una tanto impossibile quanto assurda e sbandierata autonomia.
Per questo i sindaci dei territori che piangono sulla perdita della "loro" banca sanno di piangere lacrime di coccodrillo, perché avrebbero potuto spendersi prima per orientare l'opinione pubblica e i votanti; per questo tutti coloro che si sono adoperati per respingere la proposta di Banca Popolare del Lazio sanno che ora della gloriosa Banca Popolare Valconca non resterà pietra su pietra anche grazie a loro. Perché compito dei commissari, soprattutto nell'ambito delle nuove procedure di risoluzione europee (BRRD), è di trovare una strada per tutelare i depositanti, qualunque essa sia. Non il marchio, non il nome, non la storia: i depositanti. Certo, gli stessi commissari potrebbero decidere di dare quel che resta di BPV alla stessa Popolare del Lazio, ma a condizioni liquidatorie. Potrebbero, ove vi fossero le condizioni -ma ne dubito- tentare di salvaguardare uno o più rami di azienda ritenuti sani (gli sportelli? quali?) per provare a proseguire in una continuità che non potrà che essere insieme con un'altra banca: e a questo punto, a insindacabile giudizio di Bankitalia, l'assemblea non c'è più.
Chi ha fatto promesse mirabolanti di valori delle azioni superiori a quelli di mercato, si dovrebbe vergognare perché, immemore di quanto già accaduto in Veneto Banca e in Popolare di Vicenza, ha continuato a speculare sul valore della Banca, pur conoscendone benissimo l'entità.
E' significativo che ora i sindaci dei più importanti comuni interessati si dispiacciano, mentre non si lamentavano certo quando la banca, complici i valori "autodichiarati" sempre in aumento, riempiva il libro soci di soggetti che nulla avevano a che fare con il territorio, di Ravenna o di Pesaro che fossero e che, soprattutto, avevano in mente una sola cosa: speculare sul valore della banca, in continua crescita "contabile", proprio come Veneto Banca e Popolare di Vicenza.
E sia ringraziato il cielo che, almeno, in Popolare Valconca non sono state fatte le famose operazioni "baciate" delle banche venete di cui sopra.
A questo punto, anche grazie all'improvvida attività dei propagandisti dell'autonomia, di banche locali nel territorio riminese ne sono rimaste tre, tutte e tre peraltro, in ossequio alla riforma del 2016, facenti parte di grandi gruppi nazionali, sia pure cooperativi. Anche di questo si dovrà riparlare in questa sede e molto presto. La crisi nazionale e internazionale incombe e non aspetta.
Alessandro Berti
Rosita Copioli, I fanciulli dietro alle porte
I fanciulli dietro alle porte, ultima raccolta di poesia di Rosita Copioli, trae il titolo da Giacomo Leopardi, che ne fa l’estrema immagine del desiderio. Intorno al 16 settembre 1823 Leopardi leggeva il Simposio di Platone e Saffo, riflettendo sullo spavento della bellezza, dell’amore, dell’estrema ricerca del Tutto: l’infinito “impossibile”. Concluse scherzosamente: «i desideri come son penosissimi nella lor durata e nel loro corso, così riescono spaventosi nella lor nascita (e più quel d’Amore, ch’è più penoso, perché più forte; massime negl’inesperti). E si dice per ischerzo, ma non senza ragione di verità, che bisogna soddisfare ai desiderii de’ fanciulli per non trovargli morti dietro alle porte». (Zibaldone, 3443-46).
Come in ogni suo libro, fin dall’esordio con Splendida lumina solis che le valse il premio Viareggio opera prima nel 1979, ne I fanciulli dietro alle porte Rosita Copioli offre una configurazione nuova. Qui, intorno al desiderio, ossia al mistero che muove il cuore umano con le stesse pulsioni della natura, intesse nel linguaggio ogni ritmo e forma: liquida lirica, concentrazione icastica, timbro prosastico, onde poematiche, dramma, gnome e poesia civile. Riporta in scena le grandi tradizioni classiche e romantiche, il mito e la filosofia, dove ha inseguito soprattutto il tema di Elena, la bellezza, la sua immaginazione fiammeggiante, intrecciando sempre il suo lavoro critico e di saggista, con quello della poesia.
Dodici quadri inscenano le accensioni del desiderio come fuoco, nelle varianti estreme, e nelle loro opposizioni. Dapprima è il seme del fuoco e dell’eros. Ma ecco le tre figure di Prometeo, Lucifero, san Francesco, dove tenebra e luce rappresentano il bene e il male in diverse teologie: Lucifero si allontana da Dio verso la tenebra, ma era la prima stella del mattino, Venere, «che d’amar conforta»; l’islamico Iblis è paradossalmente il più santo nato dal fuoco; Prometeo, con la sua hybris generosa è generatore di guerre; san Francesco è il fuoco dell’uomo-Cristo che arde come un sole. Terzo quadro, la storia dei conflitti, dove quello recente di Iugoslavia, a un passo da noi, ricompare nelle vertigini di un invisibile di luoghi e tempi, a specchio di quelli di oggi, tra Oriente e Rimini. Così poi, nel quotidiano delle origini, riaffiora una Romagna che conserva il profumo del Vangelo e di Pascoli, tra i simboli delle tradizioni: san Giovanni e san Martino, emblemi straordinari del contrasto luce-tenebra che è lotta per la vita. La dialettica della realtà si rispecchia in un gioco di rimbalzo, di collassi di stelle e buchi neri tra calore e freddo massimi, di espansioni e contrazioni, che i nostri corpi e le nostre anime e le nostre arti esprimono inconsciamente e simbolicamente: forse la prima cifra del desiderio. Dall’ottava sezione Uccelli sotto vetro, dedicata a San Miniato e alle Porte Sante, si torna a miti che nascono dal vissuto, sulla soglia di esperienze estatiche, che hanno echi di mistici persiani, di Goethe, di Dickinson.
Nel suo ultimo libro, La ragazza dagli occhi d’oro, Pietro Citati ha dedicato un capitolo a Rosita Copioli, che già aveva salutato come «la più intensa e ricca poetessa italiana di oggi». Era stato il primo dei lettori di questo libro. Mentre queste sono alcune parole scritte a caldo da Giuseppe Conte: «folgorato dall'inizio, dal fuoco, dall'eros, dal lirismo assoluto delle prime poesie. E poi dalla rivisitazione di Prometeo, e dalla caduta di Fetonte, tema che mi prende alla gola. Poi mi porti in Jugoslavia, lì c'è la storia, il grido! Compaiono Fiume e D'Annunzio e la sua Carta del Carnaro, un modello assoluto, perdente e assoluto, di libertà... Hai un respiro enorme. Il libro ha un respiro enorme. Questo devo dirtelo subito, con ammirazione. ... era troppo urgente dirti quello che ho sentito... ho finito di leggere il tuo libro, sempre cavalcando nel fuoco e nell'estasi di una ispirazione che travolge. La seconda parte del libro è fedele alla prima Ci sono due testi in prosa ma il resto è lirismo epico, duro, generoso, pieno di dolore di gioia, come è sempre il cuore di chi ha cuore (Was soll all der Schmerz und Lust?, cantava Goethe). A me piace quando giochi con la luna, luna felina, flessuosa regina, quando parli del profumo di tuo figlio, mi incanta il sapere aspro, terragno di "Il regno del campo" e la parabola Sufi di Salomone che dialoga con la formica, bellissima la energia amorosa di Scrivevo un tempo, di Misura della pelle e delle ossa, c'è in te fuoco, follia, estasi («toglietemi tutto fuorché lei»!!!) e nessuno può neanche attenuarli. ... Sono molto colpito da questo tuo libro che inizia con il fuoco e continua sino alla fine nella sua luce, ma ti conosco abbastanza per dirmi che dovevo aspettarmelo. Un grande libro di vita, dolore, amore».
Rosita Copioli, I fanciulli dietro alle porte, Vallecchi Firenze, pp. 192, euro 16
Presentazione del libro Sabato 10 dicembre, ore 17 Biblioteca Baldini Santarcangelo
Luca Cesari dialoga con l'autrice

Banca d'Italia commissaria Banca Popolare Valconca
Questo il comunicato della Banca Popolare Valconca.
Nell’esercizio dell’azione di vigilanza, la Banca d’Italia ha adottato una misura di intervento precoce nei confronti di Banca Popolare Valconca Spa (con sede legale in Morciano di Romagna), con l’obiettivo di assicurare un adeguato presidio dell’operatività della banca e di ripristinare condizioni di sana e prudente gestione.
Pertanto, è stato disposto lo scioglimento degli Organi con funzioni di amministrazione e controllo di Banca Popolare Valconca Spa, che dal 3 dicembre 2022 è in amministrazione straordinaria, ai sensi dell’articolo 70, comma 1, del Testo Unico Bancario; sono stati altresì nominati il dott. Francesco Fioretto e l’avv. Livia Casale, quali Commissari straordinari; l’avv. Andrea Grosso, l’avv. Dino Donato Abate e la dott.ssa Simonetta Di Simone, quali componenti del Comitato di Sorveglianza.
La gestione di Banca Popolare Valconca Spa è stata temporaneamente affidata a tali Organi e rimane oggetto di supervisione nell’ambito dell’azione di vigilanza ordinaria svolta dalla Banca d’Italia.
Banca Popolare Valconca Spa, prosegue la propria attività e, pertanto, la clientela e i depositanti possono continuare ad operare presso gli sportelli con la consueta fiducia.
Banca Popolare Valconca. Il buio oltre la siepe
L'assemblea dei soci della Banca Popolare Valconca, nel corso dell'assemblea di domenica scorsa, con una maggioranza non schiacciante ma comunque tale, ha deciso di rifiutare le nozze con Popolare del Lazio. Per fare cosa? Per andare dove? Il rifiuto espresso dal voto pare più una ripicca tesa ad affermare la legittimità della propria autonomia e indipendenza che non il frutto di un progetto alternativo. Non risultano all'orizzonte "cavalieri bianchi", che peraltro non arrivano quasi mai, nonostante qualcuno ne vociferasse, con il rischio di distorcere le informazioni al mercato e di commettere aggiotaggio. L'assemblea ha votato no e, per carità, legittimamente: ma con quali prospettive?
Al 31.12.2022 scade la cosiddetta phase-in, ovvero il periodo durante il quale non entreranno a pieno regime gli standard di Basilea 3. Come ricordava a un convegno accademico il vidirettore della Vigilanza di Bankitalia, Pilati,"la pandemia COVID19 ha imposto un ripensamento dei tempi previsti per l’applicazione delle nuove regole. Nel marzo dello scorso anno, il Comitato di Basilea – con il pieno sostegno della Banca d’Italia – ha deciso di rinviare di un anno, all’1.1.2023, l’entrata in vigore degli standard di Final Basel III per aumentare la capacità operativa delle banche di fronteggiare le sfide della pandemia."
Ora è abbastanza evidente che non ci sono alternative, tranne quella che, nonostante la moral suasion di Bankitalia, è stata poi rifiutata. Il concambio con Blu Banca, che a taluni non piaceva, rifletteva, peraltro, la situazione della Banca Popolare Valconca anche in termini di capacità del patrimonio, ormai assai ridotto, di assorbire le perdite su crediti
Dunque al 1.1.2023 entreranno in vigore nuove regole, più restrittive, dalla cui applicazione derivano conseguenze di immediata evidenza per Banca Popolare Valconca; la scelta di non dare seguito al progetto di fusione avvia, a mio parere, decisamente la banca verso provvedimenti straordinari dell'autorità di Vigilanza.
Un salto nel buio: perché?
Alessandro Berti
L'anarchico e il religioso: la statura dell'uomo secondo don Giussani
Che cosa accomuna Amilcare Cipriani e Alberto Marvelli? Niente, verrebbe da dire d’istinto. In effetti, a parte la comune origine riminese, cosa può tenere insieme il campione dell’anarchia e il grande testimone di fede che la Chiesa ha proclamato beato? Anarchia e fede religiosa sono agli antipodi. Eppure…
Eppure, il pensiero di don Luigi Giussani, al quale fino al 27 novembre è dedicata una mostra nel cortile della Biblioteca Gambalunga, offre una prospettiva diversa, originale. Secondo il sacerdote milanese, del quale si celebra il centenario dalla nascita, «solo due tipi d’uomini salvano interamente la statura dell’essere umano: l’anarchico e l’autenticamente religioso». Un paradosso che Giussani spiega in questi termini: «La natura dell’uomo è rapporto con l’infinito: l’anarchico è l’affermazione di sé all’infinito, e l’uomo autenticamente religioso è l’accettazione dell’infinito come significato di sé».
Entrambe le posizioni salvano la statura dell’essere umano, ma non sono alla pari: «l’anarchia costituisce la tentazione più affascinante, ma è tanto affascinante quanto menzognera». L’anarchico tende a dire «io mi affermo contro tutti e contro tutto», ma, osserva Giussani, «è molto più grande e vero abbracciare la realtà e l’essere, piuttosto che affermare se stessi di fronte a qualsiasi realtà».
L’attenzione di Giussani alla posizione anarchica ha probabilmente anche delle ragioni biografiche. Non tutti sanno che il padre Beniamino, militante socialista, era stato in rapporto con Anna Kuliscioff, anarchica rivoluzionaria russa, compagna di Andrea Costa, il romagnolo primo deputato socialista in Italia. Dal loro rapporto nacque Andreina, che andò in sposa a Luigi Gavazzi, rampollo della famiglia titolare della fabbrica dove lavorava il padre di Giussani. Andreina si convertì al cattolicesimo e, probabilmente tramite il parroco di Desio, entro in rapporto con Angela, la mamma del futuro sacerdote. Se Giussani ha potuto continuare gli studi in seminario, è stato grazie al fatto che Andreina ha pagato le rette. Insomma, il futuro fondatore di Comunione e Liberazione è diventato prete grazie alla figlia di due massimi esponenti dell’anarchia prima e del socialismo poi.
Tornando a Rimini, è interessante notare che la città è sempre stata considerata un covo di anarchici. Non solo per lo storico nucleo che si sviluppò nel Borgo San Giuliano e che provocò qualche grattacapo alle autorità. Al di là del fenomeno storico e politico, ormai concluso, sono in molti a ritenere che l’anarchia faccia parte del carattere dei riminesi. Sono tendenzialmente individualisti, facilmente litigiosi, restii a unirsi in un progetto comune. I riminesi poi sono anche romagnoli, anche se di confine, e ciò conferisce loro un carattere sanguigno, caldo e appassionato. Sono pronti a spendere energie, se intravedono un ideale che li convinca. Ed anche ad attaccar briga con chiunque si frapponga ai loro progetti. Una miscela esplosiva il carattere anarchico romagnolo. Si può dire che qui, fra l’Arco e il Ponte, i due tipi umani, l’anarchico e il religioso, si siano sviluppati al massimo, ed anche incontrati, scontrati, e probabilmente anche capiti.
Don Giussani amava i riminesi. Dagli anni Sessanta in poi, dopo che anche a Rimini era nata Gioventù Studentesca, ha molto frequentato la città. Dopo la crisi del Sessantotto nella Rimini anarchica e individualista è cresciuta una fiorente comunità di Comunione e Liberazione. «Rimini è un po’ una seconda patria di questo movimento», ha osservato di recente il vescovo Francesco Lambiasi. C’è qualche connessione fra il carattere dei riminesi e l’accoglienza data al carisma di don Giussani? C’è sicuramente qualche indizio che i riminesi piacessero a don Giussani proprio per la loro indole. Bruno Sacchini, uno dei primi giessini, ricorda una visita di don Giussani nella sede di via Cairoli ed una frase di commiato: «soprattutto non perdete mai l’anticonformismo che caratterizza voi romagnoli». Cosa intendeva? Tutto il suo pensiero lascia pensare che in quella parola «anticonformismo» intendesse apprezzare la loro volontà di non piegarsi al potere dominante, di non lasciarsi intruppare, di essere aperti alla realtà piuttosto che alle ideologie. Forse li voleva richiamare al fatto che «l’esigenza della bontà, della giustizia, del vero, della felicità, costituiscono il volto ultimo, l’energia profonda con cui gli uomini di tutti i tempi e di tutte le razze accostano tutto». Solo la scoperta delle esigenze originali del cuore, salva l’anarchico, o l’anticonformista, dalla tentazione di farsi lui stesso infinito.
Valerio Lessi
Gambini, una banca della ‘capacità edificatoria’ per immobili turistici
La storia delle destinazioni turistiche conosce bene il declino di località un tempo affermate e la loro sostituzione con nuove mete. È un rischio che corre anche la nostra riviera perché, mentre i mercati della vacanza cambiano e diventano più esigenti, noi continuiamo a proporre un prodotto ripetitivo e datato.
Abbiamo disperatamente bisogno di una intensa stagione di profonda ristrutturazione del patrimonio ricettivo, di una dotazione rinnovata di nuovi standard per servizi moderni sul territorio, di modificare e rigenerare una matrice urbana obsoleta che risale agli anni ’60. La mano pubblica, per perseguire questi obiettivi, ha realizzato recentemente investimenti anche molto ingenti, ma senza un nuovo quadro normativo che stimoli l’investimento privato, rivitalizzi la voglia di fare impresa, attragga nuovi capitali e nuova imprenditorialità, lo sforzo sostenuto rischia di essere vano. Perché riparta un ciclo positivo occorre restituire al mercato degli immobili turistici quella fluidità che è stata congelata negli ultimi anni dalle posizioni di rendita immobiliare.
Può essere fatto rispettando gli indirizzi delle norme urbanistiche regionali senza cioè aumentare l’impermealizzazione complessiva del territorio e senza incrementarne la capacità edificatoria, al netto delle premialità legate all’efficientamento energetico e alla sicurezza antisismica. Nella zona turistica, infatti, abbiamo già un patrimonio edilizio esistente che potrebbe ampiamente soddisfare, in una chiave di rigenerazione urbana, le esigenze di una nuova stagione di qualificazione della nostra offerta. Il problema è la sua allocazione, frutto della crescita tumultuosa e disordinata dei decenni passati, che pur scontando la crisi e la chiusura di tante imprese, costituisce il blocco alle profonde trasformazioni di cui abbiamo bisogno. Occorrono nuovi strumenti capaci di stimolare ed incentivare il mercato immobiliare ad agire secondo obiettivi di sistema.
Immagino una società pubblico/privato che diventi una sorta di banca della capacità edificatoria, alla quale possano essere ceduti o conferiti immobili turistici senza ormai alcuna ragionevole prospettiva di successo economico, che sarebbe utile abbattere per fare “respirare” la trama urbana e rigenerarla, dotandola degli spazi e dei servizi che oggi mancano. Alla stessa società potranno rivolgersi, per acquisire la capacità edificatoria di cui non dispongono, le imprese turistiche che intendono innovare, crescere e adeguare la ricettività alle fasce di mercato più esigenti.
Se avessimo uno strumento di questa natura, potremmo interpretare in modo più intelligente la rimozione del vincolo di destinazione d’uso per le strutture alberghiere, finalizzandolo principalmente alla qualità urbana del nostro sistema di accoglienza e scoraggiando la loro trasformazione in edilizia residenziale. Dovremmo anche valutare, sempre privilegiando l’aspetto della qualità urbana, le possibilità di reale utilizzo della nuova capacità edificatoria acquisita, comprendendo in ciò l’opportunità di modificare lo sky line di alcune porzioni della zona mare.
Per fare girare un meccanismo di questo tipo, tuttavia, è necessario nuovo carburante che solo in parte oggi è nella nostra disponibilità. In primo luogo, un quadro legislativo che lo consenta e lo disciplini. Si possono cercare molte strade nuove, ma migliorare norme esistenti mi sembra in genere la via migliore e più veloce. L’articolo 120 del testo unico degli enti locali prevede già le Società di Trasformazione Urbana (STU), agganciare lì una nuova disciplina per il turismo non mi sembra impossibile. Decisivo dovrebbe essere inoltre un ventaglio di incentivi fiscali che premi (dalla detassazione delle compravendite immobiliari, alla radicale riduzione del periodo di ammortamento degli investimenti effettuati o ai crediti di imposta) chi partecipa ed interviene nell’ambito delle nuove STU turistiche. Occorreranno anche risorse finanziarie per fare partire il programma di acquisizioni di capacità edificatoria. Si tratta, tuttavia, di un fondo di rotazione che verrà progressivamente nuovamente alimentato dalle cessioni previste.
L’altro carburante deve venire da un riesame puntuale delle previsioni urbanistiche della zona turistica che consenta maggiore flessibilità nel rapporto tra pianificazione pubblica ed iniziativa dei privati. Un censimento dei molti alberghi e pensioni fuori mercato ed ormai chiusi o sul punto di chiudere può essere utile per cominciare a disegnare il nuovo spazio urbano che potrebbe essere realizzato sottraendo o trasformando in servizi quelle edificazioni. La medesima flessibilità dovrà essere usata per i punti di atterraggio delle capacità edificatorie cedute. In questo caso il tema fondamentale diventa quello dell’altezza degli edifici e delle porzioni di territorio che possono essere interessate dal cambiamento dello sky line.
Infine, c’è un impegno importante che, nel partorire una nuova strumentazione normativa che consenta di incidere in modo così profondo nei meccanismi dell’economia locale, non può essere disatteso: è la sua trasparenza, l’evidenza pubblica di ogni acquisizione e cessione, il rifiuto di piegare le norme per favorire interventi ad personam, la definizione di regole che valgano per tutti e che siano effettivamente riscontrabili.
Si tratta di un disegno troppo ambizioso? Forse, ma una cosa è certa, non è il piccolo cabotaggio che ci salverà. Roma, Bologna, Rimini. Non riusciremo a scongiurare una prospettiva di declino, se non saremo capaci di muoverci nelle diverse sedi con un disegno comune. Un patto per la riviera non dovrebbe essere impossibile, le elezioni sono lontane, la politica può dare il suo meglio.
Sergio Gambini
Banca Popolare Valconca, la replica di Vanzini
Per cercare di confutare alcune mie osservazioni fondate sui pochi numeri certi che abbiamo a disposizione è andato a scomodarsi un “Professore associato di tecnica bancaria e finanza aziendale presso la Scuola di Economia dell’Università degli Studi di Urbino” (come recita la firma del suo intervento su Buongiorno Rimini), il Prof. Alessandro Berti. Purtroppo per lui e per i lettori però, il Professore deve aver dato solo una scorsa un po’ distratta ai miei numerosi articoli pubblicati su “La Piazza” (cartacea ed online), come dimostra il fatto che non riporta neppure correttamente il mio nome (ovviamente ben visibile e chiaro in tutti gli articoli) e mi chiama Giuseppe invece che Gianfranco…(Prof. è un errore blu)
Non replicherò pertanto a quelle affermazioni che non riportano correttamente il mio pensiero (chiaramente ricavabile dagli articoli che ognuno può andare a leggere se non l’ha già fatto), ma mi limiterò a poche considerazioni, la prima delle quali parte dalla paradossale conclusione del pezzo del Professore: “valutare un’ azienda, così come una Banca, nel modo che invita a fare Vanzini, significa adottare un’ottica di liquidazione, ovvero proprio quella che egli dice di voler evitare”.
Caro Professore, non devo essere certo io ad insegnarle che la fusione per incorporazione produce ex lege l’estinzione della società incorporata, cioè la Banca Popolare Valconca. (Effetto, se ce ne fosse bisogno, chiaramente esplicitato nel progetto di fusione, come ho più volte ricordato). Cioè, se non fosse ancora chiaro a qualcuno, magari per la voluta confusione che su questo punto fanno i comunicati ufficiali della Banca, la Banca Popolare Valconca dopo oltre 110 anni di storia, si estingue, muore, non esiste più.
Ma allora, Lei dice che il mio modo di valutare la Banca adotta “un’ ottica liquidativa”, non Le pare che dovrebbe essere proprio il metodo adottato nel nostro caso? Nel nostro caso infatti parliamo di estinzione della banca, poiché estinzione e liquidazione producono lo stesso risultato non le sembra giusto guardarla anche in un’ “ottica liquidativa”? Ma, andiamo avanti e cambiamo ottica, vediamo il tutto con un’ottica di continuità, come dice lei. Da esperto, analizzi con un po’ di attenzione di Bilanci, unici dati certi e confrontabili, di Blu Banca e BPV, le sembra che Blu Banca valga 13,3 volte la Banca Popolare Valconca? Perché questo prevede questo progetto di fusione.
Dopo la fusione il 93% del Capitale (quello, come lei ben sa, in base al quale si determina chi comanda e come si dividono gli utili prodotti) sarà di proprietà degli attuali soci Blu Banca e il 7% sarà dei soci (tutti) della Banca Popolare Valconca. Mi ripeto, ma a volte le ripetizioni servono, i soci BPV saranno una piccola minoranza , con il loro 7% saranno 13,3 volte meno importanti del 93% dei soci Blu Banca. Che avranno fatto un affare. Avrebbero conquistato una banca senza spendere un soldo emettendo solo 37.501 azioni date ai vecchi soci BPV. Bravi!
Qualcuno ha parlato di dividendi futuri, facciamo anche qui due conti semplici. Ipotizziamo che la nuova Blu Banca produca un utile di 5 milioni di cui 4 da distribuire ai soci (ipotesi scolastica professore) di questi 4.000.000 il 93% cioè 3.720.000 andranno ai soci Blu Banca e 280.000 euro (cioè il 7%) ai soci BPV. Se volessimo vedere quando renderebbe una vecchia azione BPV c’è da spaventarsi, perché occorre dividere 280.000 euro per 10.575.207 e si ottiene un dividendo di euro 0,026 per azione.
Caro professore concludo con una sola domanda: le sembra equo e corretto il rapporto di cambio proposto che relega i soci della BPV ad essere valutati 13,3 volte peggio di quelli Blu Banca? A me No! Per cui voto e consiglio di votare no. A fusione bocciata se è vero (come credo) che i conti sono a posto ed è solo questione di capitale, qualcuno (magari la stessa Blu Banca) potrebbe seguire l’idea suggerita da Bertoldo e pubblicata sempre su La piazza on line qualche tempo fa, che per chi non la avesse letta riporto in calce.
«Un’idea di Bertoldo (poco “esperto” ma saggio). Ragazzi perché tribolare tanto per salvare la BPV, quando c’è Blu Banca che è disponibile e ha i mezzi per farlo. Oggi la BPV ha un Capitale sociale euro 27.284.034 diviso in 10.575.207 azioni. La Banca ha bisogno di capitale perché quello che ha non basta, la Banca d’Italia richiede una iniezioni di liquidità di un ventina di milioni.
Proposta di Bertoldo . Il Cda di BPV, d’accordo con i vertici di Blu Banca, delibera un aumento di capitale a pagamento, con l’impegno di Blu Banca di provvedere alla sottoscrizione per intero, emettendo 10.575.208 azioni al prezzo di euro 1,892 per un totale di entrate 20.008.293. Cioè i venti milioni che servono alla BPV per stare tranquilli. A questo punto il capitale sociale di BPV diventa 47.292.327 (27.284.034 più 20.008.293) detenuto per il 50% più una azione dai soci Blu Banca e per il 49,999..% dai vecchi soci BPV. Blu Banca in questo modo ha la maggioranza assoluta del Capitale Sociale e la direzione e la gestione in toto della banca, mantenendo viva e rafforzata la BPV. Blu Banca che ha più volte affermato di avere liquidità sufficiente per ogni evenienza, con 20 milioni mette in sicurezza la “sua” banca e mantiene le insegne della Banca Popolare Valconca che hanno comunque un valore affettivo e concreto. Non fosse altro per la sua clientela fedele e affezionata da oltre 100 anni. La Banca Popolare del Lazio acquista la veste di holding con due partecipate: Blu banca e Banca Popolare Valconca. I soldi che Blu Banca investe sono tutti nella “sua” Banca, le azioni potrebbero avere un mercato da subito, e il territorio potrebbe continuare a usufruire dei servizi della BPV, quale componente attiva della Holding Banca Popolare del Lazio. Brava gente a me sembra una buona idea e a Voi? Saluti da Bertoldo.»
Egregio prof. Berti spero di averle dato qualche altro elemento di riflessione che le faccia capire che il rapporto 13,3 è chiaramente sbilanciato per cui non merita di essere approvato.
Dott. Gianfranco Vanzini
Abbiamo offerto volentieri lo spazio al dott. Vanzini per una sua replica e ci scusiamo per l’errore sul suo nome.
Allo stesso tempo ci permettiamo di notare, dato che siamo intervenuti più volte sull’argomento, che il problema sostanziale rimane quello delle dimensioni adeguate ad operare in un mercato che si sta polarizzando e concentrando. In questo senso, a proposito del suggerimento di Bertoldo, bisogna ricordare che per fare un affare bisogna essere in due: è del tutto evidente che, visti i problemi di BPV, la vicenda non poteva essere risolta da un’iniezione di liquidità fine a sé stessa e che non sarebbe certo convenuta a Popolare del Lazio. E tutti abbiamo presente l’ultima raccolta in Carim per evitare un destino segnato che si è trasformata in perdita secca pesante per coloro che hanno creduto o si sono fatti convincere da una ipotesi di ‘resistenza’ a tutti i costi.
Nell’ottica della fusione da tempo caldeggiata da Banca d’Italia, è certamente legittimo contestare la valutazione delle due controparti effettuata dal perito indipendente nominato dal Tribunale, ma rappresenta comunque una ammissione implicita del percorso avviato: percorso che, senza l'intervento di Banca Popolare del Lazio, non sarebbe stato neppure ipotizzabile. A meno che non si voglia, appunto, interrompere il processo stesso, rischiando un quasi certo commissariamento da parte di Banca d’Italia. Se si vuol essere davvero certi che la banca sparisca, non abbia nemmeno un consigliere e, soprattutto, veda sparire il marchio, questa sarebbe la strada migliore.
(rg)
Gambini: turismo, nuovi strumenti per rigenerare la voglia di fare impresa
Il memorabile sindaco di Rimini Walter Ceccaroni, ha narrato che, nei primissimi anni del dopoguerra, propose con insistenza a molte famiglie di mezzadri del forese di abbandonare le attività agricole e di trasferirsi sul litorale per diventare imprenditori del turismo. Sinceramente non so dire l’entità reale del fenomeno, in ogni caso la testimonianza segnala una delle principali preoccupazioni di chi guidava allora la nostra comunità. Non sarebbe stato possibile avviare la crescita del turismo, secondo un modello basato sulla piccola impresa, se non ci fossero state risorse umane con esperienza ed attitudine imprenditoriale per farlo decollare. La mezzadria nei decenni le aveva prodotte ed a questa miniera di “capitale civile” pensò di rivolgersi Ceccaroni per fare partire Rimini.
Questo mi è venuto in mente leggendo le osservazioni che alcuni esperti hanno recentemente avanzato sul sistema turistico del riminese. La cosa che più mi ha impressionato è la stima sugli immobili alberghieri in vendita e sull’esodo progressivo e costante dal settore della tradizionale componente familiare dell’imprenditoria locale. A ciò si associa la mancata sostituzione con nuovi protagonisti, l’obsolescenza della matrice di gestione aziendale e l’incapacità di attrarre nuovi investitori. Senza voglia di fare impresa è legittimo attendersi il progredire di un lento declino, di cui peraltro si avvertono già numerosi sintomi, un arretramento della competitività della nostra destinazione e dei nostri prodotti.
Al netto dell’andamento più o meno fortunato delle ultime stagioni, ciò che emerge, infatti, è una sostanziale stagnazione e ripetitività dell’offerta turistica, cui corrisponde un assestamento verso fasce di mercato medio basse della domanda.
Si riscontra una scarsa spinta all’innovazione del prodotto turistico. Le contingenze favorevoli che hanno visto nel corso dei decenni, spesso in corrispondenza di eventi critici come quello delle mucillagini, mutare, integrare e rinnovarsi il prodotto grazie a nuove idee e nuovi investimenti pubblici e privati, non sembrano avere più la forza di riprodursi.
Non è così ovunque. Il tunnel della pandemia che si è saldato con la crisi energetica conseguenza della guerra in Ucraina, sta rapidamente cambiando i mercati della vacanza. Si registra un grande interesse da parte di investitori internazionali per il brand turistico italiano, per la sua ricchezza e varietà di proposte. Località che abbiamo sempre considerato assai meno attrattive della nostra stanno calamitando investimenti importanti mirati ad un’offerta di fascia medio-alta. Jesolo per esempio.
Al contrario noi viviamo un reale pericolo di esaurimento del “capitale civile” autoctono, rappresentato dall’imprenditoria diffusa e di progressivo abbandono delle attività turistiche come asse portante dell’economia e della società locale. A causa di ciò la riviera di Romagna può essere condannata a restare ai margini dei cambiamenti in corso ed essere destinata a diventare la bella addormentata del turismo italiano.
Per il suo risveglio, come è evidente, non è bastata l’ambizione e la grande mole di investimenti che la mano pubblica ha realizzato negli ultimissimi anni nel comune di Rimini ed in molti di quelli limitrofi. Sul versante privato il quadro normativo esistente non ha certo incentivato investimenti e innovazione.
Cos’è che non funziona e rischia di renderci incapaci di adeguare la nostra offerta ai cambiamenti del mercato della vacanza?
C’è una rigidità complessiva del nostro sistema che lo condanna a ripetere all’infinito il modello attraverso il quale si è affermato nei decenni passati.
Prevalenza di strutture ricettive di piccole dimensioni, con conseguente difficoltà di adattarle ai nuovi standard della domanda; prevalenza di imprese a gestione famigliare inadeguate a perseguire progetti di accorpamento o di investimento importanti; servizi collaterali all’offerta alberghiera fortemente datati e non corrispondenti alle attese attuali dei consumatori; tessuto urbano indelebilmente segnato dalle edificazioni passate e da esse reso praticamente immodificabile.
Un circolo vizioso nel quale si intrecciano assetti proprietari fortemente condizionati dalla rendita immobiliare, regolamentazione pubblica dalla forte impronta vincolistica e assenza di strumentazione fiscale e finanziaria capace di incentivare i nuovi investimenti. Un circolo vizioso che purtroppo va ben al di là dei noti ostacoli a fare impresa che affliggono il nostro paese.
Gli obiettivi di rigenerazione e qualificazione urbana, che pure sono stati dichiarati da tutti i protagonisti della pianificazione territoriale nel corso degli ultimi decenni, nella fascia di maggiore concentrazione delle attività turistiche, sono rimasti sostanzialmente inespressi.
Il fallimento più eclatante è quello delle previsioni del Piano Paesaggistico Regionale. Dopo 35 anni, nessuno lo può negare, quei vincoli hanno consegnato immobili e porzioni strategiche del territorio, come le aree delle colonie, al degrado e all’abbandono, compromettendo, in modo temo definitivo, beni storici di grande pregio.
Tuttavia, anche dalla cassetta degli attrezzi cui sono ricorsi coloro che hanno avuto il compito di pianificare il territorio a livello locale, non sono arrivati strumenti davvero efficaci.
I comparti urbanistici in zona turistica, più o meno rigidi a seconda dell’evoluzione delle normative nazionali e regionali, che avevano l’obiettivo di favorire accorpamenti di strutture ricettive non hanno prodotto alcun esito. Neppure le premialità di cubatura, previste più recentemente per le ristrutturazioni, sono state sufficienti ad innestare un ciclo significativo di riqualificazione. L’unica via d’uscita, seppur farraginosa e troppo discrezionale, per immobili turistici ormai fuori mercato è apparsa l’abbandono del vincolo di destinazione alberghiero a favore dell’edilizia residenziale, penalizzando aree che avevano invece un disperato bisogno di servizi. Anche l’urbanistica improntata alla perequazione, con titoli edilizi capaci di volare ed atterrare su aree diverse da quelle di origine, non ha registrato risultati concreti.
Insomma, le “mappe” della fascia turistica da decenni non sono sostanzialmente mai cambiate.
Temo che se continueremo ad intervenire con quegli attrezzi sarà difficile invertire la tendenza, l’erosione del nostro “capitale civile” sarà veloce e inarrestabile e il nostro futuro si chiamerà declino.
Per questa ragione occorre prendere atto che bisogna rapidamente cambiare cassetta degli attrezzi. Quello urbanistico non può essere l’unico strumento di intervento da mettere in campo, da solo non funziona. Per rigenerare la voglia di fare impresa dell’imprenditoria locale ed attrarre investitori da fuori ci vogliono strumenti fiscali mirati agli obiettivi di rigenerazione urbana, non bastano i bonus e ci vogliono risorse e strumenti finanziari per attivare quella partnership pubblico privato indispensabile per superare il blocco imposto dalla rendita immobiliare.
Questa volta non serve andare a Vergiano o Gaiofana. Sono indispensabili invece risposte adeguate da Roma e Bologna.
Sergio Gambini
Sui nostri amici ‘speciali’ di Riccione morti nell’incidente
Perché siano speciali è la domanda che chiunque ne abbia incontrato i genitori o sia stato al funerale non può non continuare a farsi. Nello stadio gremito infatti siamo stati tutti testimoni del dolore e, insieme, di una strana sorpresa che ognuno poteva leggere e riconoscere sul volto delle persone accanto; la sorpresa di una corrispondenza imprevista tra noi stessi e quei ragazzi e i loro accompagnatori, ritrovata nel ricordo personale o anche solo scoperta per la prima volta nei racconti o nelle parole ascoltate durante la cerimonia.
E questa sorpresa è esattamente uno dei motivi per cui i morti che oggi piangiamo sono davvero speciali, perché nella loro umanità, emersa in modo così evidente, riscopriamo – sorpresi – la nostra, quasi costretti a ridirci cosa valga la pena, cosa ci faccia umani; quasi uno specchio davanti al quale ci si trova all’improvviso. Una ‘identità’ che traspare negli aneddoti di una ricerca testarda di soddisfazione e di compimento; di un desiderio che non si accontenta mai, che prima interrogava i loro genitori e oggi interroga ognuno di noi.
Noi, tiepidi nel nostro desiderio ormai addormentato o addirittura solo cinico. Un desiderio, il loro, invece, che noi tranquilli e pacificati borghesi (in questo ‘normali’) potremmo chiamare addirittura ossessione. Ma nella ricerca di ciò in cui la vita può trovare la propria soddisfazione non vale mettere meno di se stessi. Che siano l’amore e l’amicizia o invece la danza, l’apparire belli, piacere agli altri, ogni passo di questa ricerca ha valore eterno, perché vale per la domanda che contiene, che porta, che aspetta qualcosa nella quale infine si riveli chi siamo.
Erano trasparenti, questi nostri nuovi amici, addirittura indifesi di fronte al rischio cui ci si espone in questa ricerca. Ma come chi ancora continua il Centro 21 non erano soli, confidavano nell’amicizia che li guidava, perché qualcuno camminava con loro, più ‘grande’, ma sicuramente compagno nella stessa ricerca.
Sapevano osare, e chiunque abbia conosciuto un ragazzo down sa che è difficile metterli in riga, all’altezza sempre del desiderio che ogni uomo porta dentro di sé: veri sovversivi, amanti della vera trasgressione. Un altro motivo per cui sono speciali.
(rg)

![[Storie] Ricominciare si può. Intervista a don Burgio, cappellano nel carcere minorile di Milano](/media/k2/items/cache/1651e057b1b4808cbc0f51da19203bb1_Generic.jpg)