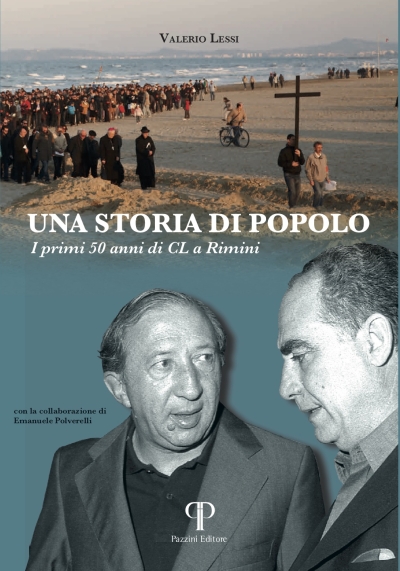Rimini, probabilmente la fine di un’epoca
Dopo i dieci anni convulsi dell’amministrazione Gnassi, tutti abbiamo pensato che una pausa di ‘normalità’, di ordinarietà, una certa misura nel governare e nel fare fossero necessarie. D’altra parte, nel suo incarico di sindaco, Andrea Gnassi è stato uno degli ultimi visionari protagonisti della vita cittadina (e dei quali, in attività, rimane ormai il solo presidente della Fiera Lorenzo Cagnoni).
Poiché dunque all’orizzonte non sembrano apparire nuove figure di questo tipo, che associno una visione personale originale e innovativa, la necessaria determinazione e le altrettanto necessarie risorse economiche e di potere, forse dovremo rassegnarci a un periodo di ‘normalità’ più lungo di una semplice pausa e nel quale, più che aspettarsi nuove ‘avventure’, sarà necessario capire come valorizzare e aggiornare continuamente ciò che fa già parte dell’identità cittadina.
Una prima conferma di questa necessità ce la offre la decisione della Fondazione Carim di ridurre le proprie quote in Unirimini, praticamente ritirandosi dall’università. Una scelta che ha il valore simbolico e anche molto concreto della fine di un’epoca, una scelta tanto evidentemente contraria alla storia della Fondazione stessa da apparire emblematica di un atteggiamento nuovo, che arriva a coinvolgere la propria identità e del quale prima non ci si era accorti. E così, che Mauro Ioli non sia Luciano Chicchi non è più solo una questione di paragoni (absit), ma pone improvvisamente e drammaticamente il tema dei ‘fondatori’ moderni di questa città e di come comportarsi con la loro eredità.
Per la continuità di contenuti e atteggiamenti che arrivano fino al presente, possiamo dire che la Rimini di oggi sia ‘nata’ negli anni Ottanta. È la città capitale della vacanza moderna - o, per meglio dire, postmoderna - che ha il suo mito fondativo nel romanzo di Tondelli, e del quale la rinascita dopo le mucillaggini appare quasi la riprova miracolosa; è la città che, da allora, è stata capace di sviluppare una sua identità originale (“di tendenza” si cominciava a dire allora) e allo stesso tempo restare comunque popolare.
Ma questa Rimini non è nata dal nulla, è figlia di una idea di città e di turismo che voleva lasciarsi alle spalle il successo degli anni ’60 e guardava a modelli e categorie culturali allora emergenti. Ma soprattutto è figlia della visione cui alcune persone, ognuna nel proprio ‘campo’, hanno dedicato la vita. Perché per ‘costruire’ una città che ambiva a diventare la città dell’accoglienza, la città dell’ospitalità, la città dell’incontro, la città per tutti, ci volevano uomini che non si accontentassero solo di mettere in piedi un business o fare carriera, che non pensassero solo a loro stessi, ma che invece avessero un sogno e la pretesa che il loro sogno potesse essere di tutti o comunque un bene per tutti.
Ognuno potrà compilare l’elenco delle ‘opere’ e dei nomi che hanno contribuito alla costruzione dell’immaginario e dell’identità riminese anche solo seguendo il filo dei ricordi o della propria partecipazione alla vita cittadina. Un elenco che comprenderà infrastrutture ed eventi, idee e immagini, istituzioni, imprese e associazioni. Solo perché più rappresentativi dell’ultimissimo periodo e anche molto diversi tra loro, qui citiamo solo l’esperienza dei forum del piano strategico, il nuovo lungomare e la rinascita popolare del basket riminese.
I nomi cui corrispondono le innovazioni che potremo elencare sono tanti e in realtà potremmo includere ogni riminese, perché il “protagonismo di tutti”, il “sentirsi parte di un progetto”, è esattamente il dono dei ‘fondatori’ e dei ‘sognatori’. In ogni caso questa visione e ciò che essa ha generato nel tempo costituisce l’eredità che ci viene lasciata e della quale dobbiamo farci carico diventandone a nostra volta protagonisti. Una dinamica, questa del passaggio del testimone, che in questi anni ha toccato naturalmente anche le principali imprese riminesi così come tanti piccoli e grandi alberghi, e allo stesso modo movimenti religiosi, associazionismo culturale e sociale; e in modo tutto nuovo ci porterà ad affrontare anche il ricambio prodotto dai bandi delle imprese di spiaggia.
Dopo i fondatori (che hanno il privilegio come i santi e gli eroi di dover servire solo la propria missione) viene sempre l’epoca del servizio, del mettersi a disposizione di un bene cui contribuiamo ma che non è nostro, che non abbiamo deciso noi, su una strada che non abbiamo tracciato.
Un mestiere per niente facile, che chiede comunque scaltrezza, intelligenza, grande energia; ma soprattuto presuppone una certa purità del cuore senza la quale il bene di tutti non è possibile (se ne può sorridere, ma è l’unico vero vanto di cui noi, uomini di questi cambiamenti d’epoca, possiamo fregiarci).
E dunque, se questo – dopo quasi quarant’anni – non è più un tempo in cui vediamo affacciarsi nuovi ‘fondatori’ e nuovi ‘sognatori’, come dovremo comportarci praticamente? Ovviamente nessuno può avanzare una ricetta, ma anche il solo porsi la domanda sarà fondamentale se potremo presupporre la possibilità di un dialogo e di una riflessione comune con chi condivide con noi la vita e la passione per questa città.
E sarebbe interessante che l’Amministrazione comunale per prima capisse e accettasse questo suo compito storico particolare, questa tutela comune, magari creando luoghi nei quali mettersi in ascolto e in dialogo con i propri cittadini. Condividere il pensiero, le intenzioni, l’atteggiamento nei confronti dell’eredità ricevuta è segno di grandezza (e nessuno potrà comunque togliere nulla alle sue prerogative di governo e di decisione).
(rg)
[Interviste] Matteo Fadda, nuovo responsabile generale della Papa Giovanni XXIII
La Comunità Papa Giovanni XXIII, fondata a Rimini nel 1968 da don Oreste Benzi, ha un nuovo responsabile generale che succede a Paolo Ramonda, in carica per quindici anni. Si tratta di Matteo Fadda, 50 anni, torinese, laureato in filosofia e tecnico informatico. Insieme alla moglie Carla vive a San Giorgio Canavese, diocesi di Ivrea, in una casa famiglia con i loro figli naturali e molti altri accolti, alcuni con gravi disabilità.
Con lei arriva alla guida una terza generazione che quasi non ha conosciuto personalmente don Oreste. I suoi amici sono stati molto coraggiosi a sceglierla. Che significato ha questa scelta?
Don Oreste lo abbiamo incontrato personalmente solo una volta, poi lo abbiamo incontrato come parte del popolo nei due anni prima che mancasse. È mancata la relazione personale, ma in quegli anni ci siamo abbeverati al suo pensiero. Ricordo che il giorno in cui è mancato è stato un giorno di smarrimento perché noi eravamo lanciati dentro questo cammino.
Però è anche vero che don Oreste ci ha lasciato la sua spiritualità e il suo accompagnamento spirituale nel Pane Quotidiano che è un dono prezioso perché è una raccolta delle sue omelie e dei suoi commenti. Quindi lo abbiamo conosciuto anche di più dal punto di vista della sua spiritualità, perché è presente nella nostra quotidianità e ci accompagna. Forse la mia generazione è la prima che incarna il mandato della Santa Sede a rinnovarci guardando con fedeltà al carisma di fondazione, il nostro carisma vocazionale. Tenendo presente che il carisma del fondatore, il carisma che ha generato tutto questo non si ripeterà più, perché lui era don Oreste unico e irripetibile. Quindi di deve distinguere molto bene fra la figura di don Oreste, che con il suo carisma personale ha ospitato lo Spirito che ha dato origine alla nostra bella comunità, e invece l’eredità che ci ha lasciato che è il carisma di fondazione. Rimanere fedeli a questo carisma e rinnovarci guardando al futuro, questo è il nostro compito. Penso che il mio mandato, di successore di Ramonda, primo successore di don Oreste, dovrà incarnare sempre di più il ruolo di moderatore, cioè il ruolo del responsabile che consente una maggiore responsabilità partecipata, valorizzando ancora i fratelli che hanno conosciuto don Oreste personalmente, quindi tutta la nostra storia, ma dando anche slancio ai giovani, al futuro della comunità. Spero di essere all’altezza perché è un compito impegnativo. Di sicuro non potrò affrontarlo da solo, ho chiesto a tutti di aiutarmi.
Perché ha scelto di aderire alla Comunità Papa Giovanni XXIII, cosa l’ha attratto?
Quello che ci ha colpito della comunità è stata questa grande apertura senza porre condizioni, se non questo impegnativo carisma che si articola nei cinque punti della nostra carta di fondazione che è molto esigente come del resto lo è il Vangelo. Un’apertura strutturata, con serietà. Quello che ci ha colpito è la serietà della struttura che la comunità si è data nel tempo, non parlo tanto di regole o regolamenti ma proprio di struttura istituzionale. Mi riferisco a tutti quelli che lavorano nella comunità per sorreggere la possibilità che le persone che ne fanno parte siano in grado di aprirsi all’accoglienza, di condividere. Queste persone dell’istituzione supportano la vita quotidiana facendo un lavoro strutturalmente importante perché permette di sorreggere il carisma. Un’organizzazione che aiuta anche nella vita quotidiana perché siamo articolati in piccoli gruppi che si incontrano ogni settimana, i nuclei; poi un incontro mensile di un ambito più ampio che chiamiamo zona; gli incontri di spiritualità periodici, le assemblee. C’è quindi un modo di sostenersi nella quotidianità che è ben piantato per terra. Questo ci ha colpiti, avevamo conosciuto anche altre realtà, ma ci sembravano forme di spontaneismo un po’ fragili. L’altro aspetto è l’apertura ai più piccoli, ai più poveri che nessuno vuole, noi in particolare eravamo orientati ai bambini, ai disabili, quindi questo ci ha fatto sentire in famiglia.
Per motivi di famiglia non potrà girare in Italia e nel mondo. Come pensa di poter guidare una comunità così articolata e complessa e diffusa in tutto il mondo?
Questa è la nostra condizione di famiglia in questo momento, nella contingenza attuale abbiamo persone accolte che richiedono un’assistenza costante, continua, quotidiana. Non ne faccio un problema di programmazione, ho invece un approccio più di fede e di speranza. Penso questo: lo Spirito Santo non si contraddice, se ha chiesto alla nostra famiglia, a me e a mia moglie di svolgere questo servizio, sono sicuro che troveremo il modo di arrivare dove c’è necessità che io sia presente. E potrà essere una presenza fisica, lo spero; o magari qualcuno si muoverà di più e verrà lui in Piemonte a trovarmi; o magari si muoverà con la mia delega qualcuno dei responsabili. Non so bene ancora come ci organizzeremo, sono sicuro che lo faremo insieme agli altri responsabili, alle zone più lontane. Non ho la preclusione a viaggiare, adesso c’è una evidente difficoltà a farlo, ma la speranza è di riuscire a trovare il modo di fare tutto bene lo stesso senza mettere in crisi la famiglia e la comunità.
Invece che il pronome “io, lei usa spesso il “noi”, per indicare lei e sua moglie…
La responsabilità è mia personale e anche le azioni di governo che farò mi vedranno impegnato in prima persona. Il legame con mia moglie si fonda sul sacramento nel quale credo e ci fa essere un noi, vuol dire che lei è parte costitutiva della mia persona. Io ho questo incarico, mia moglie ha altri incarichi in famiglia, altri pesi da portare, però se noi due saremo uniti faremo tutto. La base sicura è il fatto di rimanere uniti. Noi ci conosciamo da quando avevamo quindici anni, ci siamo fidanzati a diciannove, adesso abbiamo 50 anni tutti e due, sono più gli anni che abbiamo vissuto come coppia che singolarmente. Fa parte del mio dna.
La sua personale esperienza cosa le suggerisce sul ruolo sociale della famiglia nella società contemporanea?
Sono cresciuto con un sacerdote di Torino che diceva che il primo mattoncino sul quale costruire la nostra società è la famiglia. E ho incontrato don Oreste che ci ha detto che il primo bisogno che la persona ha è quello di avere una famiglia. Sono proprio convinto di questo, la famiglia, per come siamo stati pensati e costruiti da Dio, è la cellula base della nostra società. Se rafforziamo la famiglia invece di demolirla, di renderla liquida come si cerca di fare da tutto il Novecento, come teorizzato dai filosofi del pensiero debole e poi messo in pratica dal consumismo, se noi rifondassimo la solidità della famiglia e lavorassimo su di essa come cellula base, penso che veramente la nostra società si baserebbe su mattoncini solidi. È la battaglia del Forum, nel quale Gigi De Paolo si impegna molto.
Lei finora è stato responsabile di Operazione Colomba, il corpo di volontari che va a vivere nelle zone di conflitto. Come vive la Comunità Papa Giovanni XXIII l’invito di papa Francesco ad aiutarlo nella profezia per la pace?
Per noi è fondamentale, prioritario, lavorare per la pace. Molte persone della comunità sono state obiettori di coscienza, io anche; i giovani di Operazione Colomba sono la punta avanzata di questa natura della comunità. Ci muoviamo anche su altri fronti. Don Oreste e poi anche Paolo hanno molto insistito nel chiedere l’istituzione del ministero della pace, cioè la scelta di lavorare per una struttura diversa che imposti i rapporti fra gli stati come rapporti di pace. Inoltre diciamo da tempo che è ora di disarmare la guerra. Cosa vuole dire? Convertire l’industria che alimenta la guerra in una industria di altro genere. La nostra non è semplicemente una critica contro la guerra o contro chi produce le armi ma vogliamo essere per la pace e quindi diciamo di invertire la rotta, di fare una rivoluzione copernicana. Invece di mettere al centro il profitto, mettiamo al centro l’umanità e il diritto a vivere in un mondo di pace. Il nostro impegno è anche con le istituzioni: giovedì scorso c’è stata la conferenza stampa per chiedere il disamo nucleare, noi abbiamo partecipato insieme alle altre associazioni cattoliche.
Lei era alla guida anche di Condivisione fra i popoli, la ong che coordina l’attività nei paesi di missione. Quindi già conosce lo stato della comunità nel mondo. Che idea se ne è fatto….
Ho iniziato a conoscerla, perché da tre anni ho svolto questo incarico. La comunità Papa Giovanni è nata in Italia, è nata in Romagna, poi si è sviluppata prevalentemente in Italia, quindi ha un carattere italiacentrico. Però è stata voluta da Oreste e riconosciuta profeticamente da Giovanni Paolo nel 2004 come comunità internazionale di fedeli. L’intuizione profetica di don Oreste è di espanderci in tutto il mondo. Oggi noi siamo in 42 Paesi, dobbiamo sempre di più imparare a valorizzare questa nostra identità internazionale. In questo periodo ne stiamo parlando molto all’interno della comunità cercando di capire quali strumenti darci per valorizzare questa dimensione internazionale. Sarò il lavoro dei prossimi anni, le modalità le dobbiamo trovare insieme.
Dopo la sua elezione, Paolo Ramonda le ha consegnato la reliquia della beata Sandra Sabattini: cosa rappresenta la testimonianza di Sandra per la vita di oggi della comunità?
Sandra è un dono enorme. Mi vengono i brividi a parlarne perché molto più grande di me e della mia capacità di comprendere. Quello che colgo è che uno dei simboli che Sandra rappresenta è l’essere perennemente giovani. Sia come capacità di attrarre i giovani, di tornare a riproporre come diceva don Oreste un incontro simpatico con Cristo; sia anche come mantenerci giovani dentro, anche a 50, 60, 70, 80, 90 anni, giovani dentro come lo era don Oreste. Questo gesto di Paolo non me lo aspettavo e lo vedo come un mandato: avere sempre un occhio di riguardo ai giovani e allo spirito della giovinezza, secondo il motto di don Oreste: le cose belle prima si fanno e poi si pensano. Sandra con tutta la sua bellezza spirituale rappresenta un grande dono per noi.
Valerio Lessi
Lettera aperta del Vescovo di Rimini a Vasco Rossi
Mons. Nicolò Anselmi, vescovo di Rimini, ha indirizzato una lettera aperta a Vasco Rossi in occasione del concerto che il cantante terrà in città allo stadio Romeo Neri
Caro Vasco,
Mi permetto di darti del “tu” perché, pur senza averti mai incontrato personalmente, ti sento quasi come uno di famiglia.
Sono anni che, con amici e ragazzi, cantiamo le tue canzoni intorno al fuoco, sulla spiaggia, sotto la luna, fra le tende.
Mi chiamo Nicolò, e sono il Vescovo di Rimini. Sono nato a Genova, ho vissuto nel centro storico, e insieme alle tue canzoni spesso le chitarre intonavano le note del concittadino Fabrizio De Andrè. Volevo darti anch’io il benvenuto nella nostra città.
Hai scelto di iniziare a Rimini il tuo tour. Migliaia di giovani e adulti ti attendono, alcuni accampati da giorni fuori dallo stadio. Su molti di loro tu eserciti un’influenza potente.
In questi giorni tanti ragazzi e giovani si sono generosamente coinvolti nell’aiutare le popolazioni alluvionate della tua, nostra regione. Sono venuti da tutt’Italia, tanti anche da Rimini: molti di loro li conosco personalmente. Hanno spalato fango, lavato mobili, distribuito pasti, spostato rottami e detriti. Alla sera erano esausti ma felici; hanno servito, faticato, aiutato, amato chi si trovava in situazioni di grande difficoltà e di lutto. Tutto il mondo ha visto la loro bellezza interiore.
Permettimi ora di dire una “cosa da prete”: questi ragazzi e giovani hanno manifestato la forza e la capacità di amore di Gesù che è dentro di loro, che è dentro tutti, credenti e non credenti, di ogni religione.
Se puoi, incoraggiali – magari anche dal fronte del palco del ‘R. Neri’ – a continuare così, ad essere generosi sempre, attenti verso chi soffre, verso i malati, verso chi è straniero e fatica ad inserirsi, disponibili a tenere compagnia ad un anziano, ad aiutare un bambino in difficoltà con lo studio, a stare vicino a chi si sente solo e vuoto.
Se vuoi, invitali a non spegnere mai quel desiderio d’infinito che si trova nel cuore di ogni uomo, lo stesso che abita sulle “Dannate nuvole”.
Se puoi, suggerisci loro a non aver paura di una “vita spericolata” e ad “andare al massimo” nell’amore verso gli altri, gli esclusi, i fragili, verso tutti. Chi vuol “trovare un senso a questa vita” lo può trovare nel rendere felici gli altri. Perché chi dona la sua vita la trova, e c’è più gioia nel dare che nel ricevere.
Grazie di cuore.
Ti accompagno con la preghiera,
+ Nicolò Anselmi
Vescovo di Rimini
Il torinese Matteo Fadda eletto nuovo Responsabile Generale della Comunità Papa Giovanni XXIII
Fadda, 50enne, torinese, è stato eletto dall’assemblea generale a Rimini domenica 28 maggio 2023 al secondo turno con una maggioranza del 70%, su un totale di 203 votanti. L'assemblea generale giuridica è composta dal responsabile generale uscente, dai responsabili di zona e dai delegati che rappresentano la Comunità nelle varie parti del mondo.
Il nuovo eletto resterà in carica per 5 anni: il cambio alla guida si è reso necessario considerato che un Decreto del Dicastero vaticano per i Laici, approvato due anni fa da Papa Francesco, ha stabilito una durata massima di 2 mandati, 10 anni totali, per i responsabili dei movimenti e delle associazioni internazionali di fedeli laici.
Matteo Fadda, sposato con Carla, padre di 4 figli naturali, è in Comunità dal 2005. Con la moglie hanno aperto la casa all'accoglienza di bambini in affido e di persone senza famiglia di San Giorgio Canavese (TO), diocesi di Biella, in cui vive.
Attualmente è responsabile della Papa Giovanni a Torino ed in Liguria, responsabile di Operazione Colomba, il corpo civile nonviolento di pace della Comunità, vice-presidente dell'associazione “Senza Confini” di Asti, presidente di “Condivisone fra i popoli”, l'Ong promossa dalla Papa Giovanni per gestire i progetti nei paesi all'estero.
La Comunità Papa Giovanni XXIII opera nel vasto mondo dell’emarginazione e della povertà dal 1968. Vive come “un’unica famiglia spirituale” composta da persone di diversa età e stato di vita che si impegnano a condividere direttamente la vita con gli ultimi. La Comunità ha dato vita a 488 tra case famiglia e realtà in tutto il mondo, diversificando le modalità di accoglienza in base alle necessità dei poveri che incontra. L'associazione accoglie oggi 4.292 persone in Italia e nel mondo. Dal carisma della Comunità sono nati 35 enti giuridici nel mondo, tra cui: 15 Cooperative Sociali riunite nel Consorzio Condividere Papa Giovanni XXIII; numerosi centri di lavoro e attività commerciali come un editore, alberghi e gelaterie; la ONG Condivisione fra i popoli, che gestisce progetti di sviluppo all’estero.
Educhi se abiti il mondo. Il Corone in concerto
Si è ripetuto tante volte la celebre frase, “la bellezza salverà il mondo”. Sì, ma come? Come si coniuga questa espressione di fronte al male che nel mondo ritroviamo acuto e straziante, oppure di fronte a quel male sottile, infido, che abita le menti e il cuore dei nostri giovani e di noi tutti? Insomma, di fronte all’aridità di tante situazioni, cosa può mai significare un momento di bellezza?
Il Corone di Rimini, sabato sera, 20 maggio, alle ore 21 al Teatro Galli di Rimini terrà il consueto concerto di musica popolare titolato Canta per il Mondo, con una nuova inflessione, suggerita dall’attore e regista Gianluca Reggiani, coinvolto in occasione del decennale di questa singolare iniziativa. Le Vie dei canti sarà il filo rosso che guiderà la serata, sulla scia di una antica espressione dei popoli aborigeni: “una terra non cantata è una terra morta”. Ma come può un canto dare vita?
Un inizio di risposta si può intuire ascoltando la video intervista che ho avuto la fortuna di fare ad Andrea Nembrini, nuovo direttore della Luigi Giussani High School in Uganda, la scuola dove studiano i 18 ragazzi sostenuti con i proventi del concerto. Andrea, alla domanda “come fosse finito in Africa”, ha risposto con nettezza e immediatezza: “sono partito per una promessa di bene” (vedi e ascolta qui le parole di Andrea), indicando questa promessa come la stessa origine della scuola, nata da madri uscite dal tunnel dell’ AIDS e da una spirale di violenza inenarrabile. Non solo. Ha indicato questa “promessa” come l’origine che determina tutta la proposta educativa e didattica della sua scuola. (La storia della scuola e l’intervista integrale a Nembrini sono reperibili sul sito del Corone www.coronerimini.it).
Le parole di Andrea sono decisamente pertinenti con l’incontro di pochi giorni fa tra i docenti della scuola superiore e il vescovo di Rimini Niccolò Anselmi. Due ore di dialogo appassionato, volate via senza accorgersene. Prof di tutte le scuole (licei, professionali, tecnici, paritarie, statali) hanno testimoniato passione e trepidazione per i propri studenti. Studenti, che sono in preda a una forte fragilità ma che gridano, altrettanto forte, una domanda insaziabile di positività per la propria vita. Una domanda che spesso si esprime nella forma di un dolore sordo, inquietante e che pare spesso invincibile.
In questo contesto di grande partecipazione emotiva, ha impressionato l’atteggiamento del vescovo Niccolò. L’entrata, salutando tutti uno per uno, e la conduzione leggera, informale, trovano suggello nella conclusione, altrettanto snella, dove la sua voce si è rotta a causa della commozione per la “passione per l’uomo” ascoltata. Non possono non tornare alla mente, dunque, le parole di Andrea Nembrini. Non si cambia il mondo con un canto, ma la commozione per un accento di bellezza può incrinare la durezza del cuore, può rompere l’ordinario aprendo l’orizzonte sullo straordinario. Ed è di questo che abbiamo bisogno.
La didattica, le analisi, le risorse e i fondi sono nulla oggi, di fronte all’abisso di un vuoto che ingombra l’animo di tutti noi. Occorre una promessa di bene. Occorre per i giovani e per gli adulti. Occorre per fare scuola, se non vogliamo ridurla ad una ordinata e tranquilla gestione della disperazione.
In conclusione dell’intervista ringrazio Nembrini per averci donato parole “belle”, non trovando termine migliore per i suoi racconti così densi di umanità. Parole senza dubbio utili, edificanti, profonde. Ma prima di tutto belle. Ed è così che occorre definire la storia di Sharon, quattordicenne, rimasta incinta all’ultimo anno delle medie (in un contesto, l’Africa, in cui una ragazza che fa questo errore è cacciata e reietta) e che viene incoraggiata a terminare il percorso, accolta in classe, seguita. E lei, a fine anno, si esprime dicendo “io sono sempre più sicura di essere la ragazza più misera di questa terra, ma allo stesso tempo anche la più amata” (ascolta qui il racconto di Andrea su Sharon). E prosegue Andrea, “io voglio imparare da lei questo, io voglio potermi sentire così amato come si sente lei”, definendo questa consapevolezza come “l’avvenimento dell’educazione”.
La stessa bellezza si trova nelle parole di Andrea quando risponde alla domanda su come il loro lavoro costruisca la pace (molti dei ragazzi della sua scuola hanno conosciuto la guerra e sono stati protagonisti di violenza). Racconta la straordinaria iniziativa delle stesse donne che hanno costruito la scuola che, pur vivendo spaccando pietre, hanno desiderato inviare danaro in Ucraina, affermando che quei pochi soldi “sono le nostre lacrime di fronte a Dio, perché possa cambiare il cuore degli uomini che sono in guerra … perchè le donne e i bambini ucraini sono le nostre sorelle e i nostri figli, quel popolo ci appartiene” (qui il passo raccontato da Andrea Nembrini).
Parole che attestano la bellezza di una vita cambiata e che proiettano su di noi quella “promessa di bene” che ha reso semplice il partire di Andrea. Cosa altro è dunque la scuola se non la proiezione di una promessa di bene sui nostri studenti, così che trovino energia e intelligenza per affrontare le durezza della vita, dello studio, delle incomprensioni, del vuoto? Ed è per assaporare questa promessa che questa sera il coro, ancora una volta, intonerà i suoi canti, scoprendo e rigenerando bellezza, affinché anche noi possiamo percepirci investiti da ciò che potrà tornare a farci rialzare e camminare.
Emanuele Polverelli
[Poesia] “Nasco dal mare”, la voce di Rosita Copioli
Prendo in mano I Fanciulli dietro le porte, l’ultimo libro di poesie di Rosita Copioli, e subito da quel titolo mi raggiungono gli echi delle parole spiate, delle parole ascoltate col cuore in gola, quando da piccoli, non visti, volevamo penetrare nei segreti dei grandi che mormoravano cose proibite, dietro la porta. Apro il libro e una parte di me torna bambina, mentre si mette in ascolto di cose che non dovrebbe conoscere e arde di conoscere. L’amore, per cominciare: quello violento “come il seme del fuoco”, e di cui dietro la porta gli adulti non parlano, semmai per paura ci girano intorno. Invece Rosita spalanca la porta e ti scaglia l’amore violento in pieno petto, affinché fin da piccola io sappia cosa cercare e perché cercarlo: se vuoi esistere davvero, come le creature mitologiche, mi dice, devi provarlo, quel fuoco, fino a farti divorare. Avrai come compagni oggi Prometeo, domani San Francesco o Venere o Adamo e andrai da un luogo all’altro, fin dove ti portano le fiamme, là dove “i fuochi del cielo vivranno scendendo misti agli uccelli” e tu conoscerai i vulcani e il suo rovescio che è Hiroshima e vedrai i chiodi nei piedi di Cristo e così saprai cos’è l’amore violento, così simile alla guerra. La voce di Rosita mi prende per mano e mi porta nei luoghi dove l’Adriatico e i ricordi in principio le danno un senso di quiete – “Mia madre veniva da Fiume…”; ma dura tutto pochissimo, perché in “a questa sponda di tutto l’orrore il mostro rimosso ritorna”. È strano come la poesia, che si direbbe così lontana dall’idea della guerra, nasca insieme alla guerra, quella di Achille e della sua ira: ogni volta come la prima volta le parole diventano schegge e proiettili e le donne in guerra, dopo la casa di pietra, perdono anche l’altra casa che serbano al centro del corpo – “Appese a questo peso che cresce, che siamo e non siamo,/ a questo corpo che si dilata. Questo è il trauma che/ non cicatrizza. Bambini crocifissi prima del nascere,/ inchiodati tra sperma e sperma, a raffiche, donne dimore distrutte.” Negli anni Novanta l’Adriatico stilla sangue sulla bella Dalmazia bianca della gioventù. Ma l’Adriatico ha tanti linguaggi per chi ne ascolta gli echi e Rosita lo ascolta da sempre: è cresciuta guardando quel mare, nuotandoci dentro, parlandoci. “Nasco dal mare.”, lei scrive e io scopro leggendola che l’Adriatico non è che il proseguimento dell’Egeo: arrivano dal mare le voci antiche che nella sua poesia scandiscono parole che hanno radici lontano, in Omero, negli oracoli, nella sapienza delle profetesse folli, nei silenzi degli dei aggrottati, nelle danze delle fanciulle, nei loro ingenui ritornelli – “O luna felina, flessuosa regina,/ sull’arco del cielo/ espanso/ come la notte,/ accogli i fedeli, devoti/ alla vita dei sogni”–, finché il mondo ruotando e vorticando dentro spirali di parole diventa un unico canto continuo e le lingue si annodano una all’altra con naturalezza: il latino, il greco, l’italiano, l’antico francese e il dialetto romagnolo (questi ultimi così placidi, melodiosi e simili tra loro) giocano a specchiarsi come per la prima volta, tornati di colpo fanciulli. Io intanto, mentre volto in silenzio le pagine, mi lascio affondare nella materia liquida dei suoni e una volta in quell’acqua materna vorrei non uscirne più.
Franca Zanelli Quarantini Piancastelli
[Storie] In Opera, il lavoro come riscatto
“Quando incontri un giovane laureato in ingegneria che potrebbe facilmente trovare un buon lavoro e che invece, dopo un lockdown superato con grande difficoltà, cerca qualcosa e qualcuno che lo aiuti a ‘ricominciare’, capisci che il problema non è appena avere un’occupazione e uno stipendio, ma un luogo nel quale sia possibile trovare o ritrovare se stessi. Ancora di più in questo tempo nel quale - oltre all’handicap fisico, alla malattia mentale, al disagio sociale legato all’uscita dal carcere o dalle dipendendenze - ci troviamo sempre più spesso davanti a persone con fragilità caratteriali, attacchi di panico, che vivono con grande ansia la loro relazione con gli altri.”
Inizia così la conversazione con Giovanni Pirozzi e Chiara Colaprete, responsabili della cooperativa sociale In Opera di Rimini. E bastano poche battute per capire che il cuore della loro impresa riguarda proprio la concezione del lavoro e la crisi che ne ha modificato addirittura la natura.
Tutti vedono come sia cambiata l’idea di famiglia o l’idea stessa di persona, e così quella della religione e della politica, addirittura dello sport, e quanto siano cambiati i costumi e i valori che li definiscono; pochi invece riconoscono quanto questi cambiamenti, alla fine, si siano scaricati, pur in modi diversi, sul lavoro, sul modo di guardare e di vivere il tempo che ognuno dedica ad esso lungo le proprie giornate; di come il lavoro abbia perso un po’ alla volta ogni altro valore che non sia quello del reddito, e come le ore che si ‘porta via’ siano solo un’alienazione, qualcosa di estraneo a noi stessi, anzi, da riscattare con un’intensità sempre più spinta del cosiddetto tempo ‘libero’.
Lo racconta bene il ‘solito’ Péguy. “Un tempo gli operai non erano servi. Lavoravano. Avevano un onore assoluto, come si addice solo all’onore. La gamba di una sedia doveva essere ben fatta. Era ovvio. Naturale. Ma non bisognava che fosse fatta bene in relazione alla paga, o perché veniva pagata. E non doveva essere ben fatta per il padrone, né per gli esperti, né per i clienti del padrone. Doveva esserlo in sé e per sé. Questa gamba di sedia doveva essere ben fatta perché così voleva la tradizione, che risaliva dal profondo della razza; e così voleva la storia, l’assoluto, l’onore. E tutte le parti della sedia che non si vedevano erano perfette come le parti in vista.” (Il denaro, Piano B Edizioni, trad. Martina Grassi)
Ciò che rende originale questa cooperativa sociale di tipo B, nata ormai vent’anni fa, è appunto il non voler solo garantire un reddito a persone svantaggiate, ma di offrire loro l’occasione di un ‘riscatto’ o comunque di un’esperienza di realizzazione di sé attraverso il lavoro; e anche, una vera ‘stranezza’ in campo imprenditoriale, che per concentrarsi su questo scopo abbiano deciso di smontare e rimontare un’impresa già esistente che funzionava benissimo dal punto di vista economico, che raccoglieva grandi appalti e gestiva fino a ottocento addetti, riducendone ricavi e personale. “Sì, abbiamo deciso di non partecipare più a grandi appalti pubblici, di cercare commesse solo nella nostra regione, di ridurre progressivamente il numero di lavoratori coinvolti nella cooperativa ed essere non più di centocinquanta. In modo cioè da rendere tutto più vicino e a misura del nostro obiettivo. Una cosa possibile anche perché, man mano che le commesse che abbiamo in corso giungono a conclusione, il personale che adesso è con noi, secondo la legge, verrà assunto dai prossimi vincitori di ogni singolo bando. Un ‘rimpicciolimento’ dunque che non ha tolto comunque il lavoro a nessuno.”
Chi conosce il mondo del sociale sa bene che il rischio è proprio quello di perdere di vista l’obiettivo originale e di concentrarsi di fatto sulla sostenibilità economica della cooperativa, che invece dovrebbe essere solo lo strumento. “È un rischio sempre presente, quello di scordarsi perché hai cominciato tutto questo. E bisogna ricordarsi l’un l’altro – in particolare noi che curiamo la sostenibilità della cooperativa, che cerchiamo lavori e commesse – che non abbiamo un prodotto o un servizio da vendere, ma persone con cui abbiamo preso un impegno; e guardare ogni singolo volto senza fermarsi a ciò che lo rende diverso, alle etichette (il tossico, l’esaurito, il carcerato, l’handicappato, …), ma guardarlo come vorresti essere guardato tu.”
Questa ‘promessa’ riguarda la proposta che viene fatta a ogni persona che decide di lavorare a In Opera. “L’impegno che ci prendiamo è quello di offire a ognuno una relazione di lavoro che possa accendere le persone e rilanciarle alla scoperta di sé stesse e di ciò che può rendere piena e felice la vita. In fondo tutto nasce da una esperienza di accoglienza e di bene che noi fondatori abbiamo sperimentato per primi.”
Un impegno importante, che richiede di essere sostenuto nella pratica quotidiana. “Dal punto di vista operativo il nostro lavoro è sempre organizzato in piccole squadre, composte da persone svantaggiate e non che collaborano insieme. E abbiamo una serie di capisquadra che diventano a tutti gli effetti dei tutor personali, coinvolti direttamente nella relazione con le persone del loro gruppo e non appena degli educatori esterni, come accade solitamente, figure cioè non implicate nella quotidianità del lavoro. Con loro condividiamo i nostri obiettivi e ciò che accade nei diversi luoghi, perché sia possibile davvero valorizzare al meglio i componenti di ogni squadra. La riprova è nei fatti. Questa relazione privilegiata, questo modo di proporre e di impostare il lavoro porta a percentuali di assenza e anche di abbandono dell’impiego molto più basse rispetto a quanto succede normalmente nelle situazioni in cui sono coinvolte persone svantaggiate.”
Come ad esempio nelle aziende che, secondo la legge 68/99, sono obbligate ad assumere un certo numero di esse, che spesso vengono parcheggiate, se non addirittura nascoste, e comunque certo non ‘curate’. “La maggior parte delle commesse che sono gestite da In Opera riguardano lavori di pulizia, guardiania, portierato, call center e back office, e anche lavori manuali di fine linea produttiva. Grazie a un accordo ‘trilaterale’, sancito a livello regionale e che coinvolge le aziende, il lavoratore e la cooperativa, oggi è possibile per noi costruire volta a volta un progetto nel quale ci facciamo carico delle persone svantaggiate da assumere, fornendo con esse un servizio all’azienda che deve ottemperare all’obbligo, a volte anche nei nostri locali e comunque sempre con le attenzioni, le procedure e il lavoro in squadra che ci definiscono.”
Un’esperienza dunque innovativa e originale, ma sbaglieremmo a pensare che riguardi solo coloro che definiamo ‘svantaggiati’. Chiunque ne incroci le storie, personalmente o anche solo attraverso un racconto, non può infatti non interrogarsi sul proprio modo di concepire il lavoro e addirittura sé stesso, su “cosa renda piena e felice la propria vita”. Magari accorgendosi che persone che normalmente sarebbero espulse dal ciclo produttivo perché non abbastanza efficienti stanno indicando una strada anche a noi.
(rg)
Mencarelli alle scuole Karis presenta Fame d'aria
Metti un’ora e mezzo di incalzante conversazione sulla letteratura e i suoi dintorni, in un pomeriggio di maggio, all’ora del caffè, nell’aula magna delle scuole Karis, nell’ex colonia Comasca, con tanti posti in piedi. L’ospite è Daniele Mencarelli che almeno da tre mesi gira l’Italia, da nord a sud, per parlare sì del suo ultimo romanzo, Fame d’aria, edito da Mondadori, ma anche, e inevitabilmente, di quel mondo di solitudine, rabbia e sofferenza a cui il romanzo dà voce, o, per dirla con Mencarelli «per comunicarsi ed esprimersi dà parole che non siano quelle della burocratica diagnosi medica». Dopo la dolente trilogia autobiografica (La casa degli sguardi, Tutto chiede salvezza, Sempre tornare), il colpo allo stomaco del lettore è inflitto dalla storia di Pietro Borzacchi, un padre che letteralmente non ce la fa più a sopportare Jacopo, il figlio autistico a basso funzionamento «che non parla, non sa fare nulla, si piscia e si caca addosso». Pietro è sopraffatto dalla disabilità del figlio, ha esaurito tutte le risorse, morali e finanziarie, perché lo Stato è il grande assente di questo dramma. Pensa a una soluzione estrema, quando poi accade qualcosa…
«Considero la mia vita un gesto slanciato verso l’altro, - afferma Mencarelli rispondendo alla prima provocazione del direttore delle scuole Karis, Paolo Valentini - La scrittura per me oggi più che mai è un gesto di testimonianza a chi mi sta intorno, è una estroversione dello sguardo».
Perché questa storia di Pietro? Perché l’autismo? «Si è testimoni perché si frequentano i luoghi della realtà. Negli ultimi dodici anni ho frequentato i luoghi della neuropsichiatria infantile. Ho vissuto alla pari con il disagio degli altri. Per mio figlio l’iniziale diagnosi di autismo è poi evoluta verso un destino che possiamo chiamare più benevolo. Nelle sale d’attesa delle neuropsichiatrie sono stato sfiorato dal destino che ha colpito chi mi era vicino. Che relazione avere con gli altrui destini? Si può ragionare in termini individualisti? No, in realtà il destino in cui siamo coinvolti riguarda tutti, tutti da questo punto di vista siamo consanguinei. Sono stato a contatto con persone che rappresentano il paradigma da cui nasce il personaggio di Pietro, persone che hanno sviluppato la rabbia per la loro condizione di disagio e solitudine».
Mencarelli racconta che in Italia sette famiglie su dieci convivono con una qualche forma di disagio psichico. «Nella mia famiglia il problema ha toccato mia madre e prima di lei mia nonna. Quanto alla mia storia, devo dire che non mi sono mai riconosciuto nelle definizioni che di me dava la medicina, non ho mai accettato di essere ridotto alla diagnosi medica». Vengono in mente i dialoghi fra Daniele, il protagonista di Tutto chiede salvezza, ed i medici del reparto psichiatrico durante il ricovero per TSO. «L’uomo non può essere ridotto alla sua patologia. Per fortuna ho incontrato persone che mi hanno aiutato a leggermi in un altro modo. Mi hanno fornito più parole per potermi raccontare in modo diverso rispetto alla patologia. Ho trovato nella poesia e nella letteratura la mia vera ricchezza».
A proposito di parole, lo scrittore compie un’osservazione che ciascuno può verificare come corrispondente alla realtà. I giovani oggi per descrivere paure e disagi usano sempre più il linguaggio medico rispetto ad un linguaggio normale. Non dicono “sono preoccupato per l’interrogazione di domani” ma “sono in ansia, sono in paranoia”.
Mencarelli, a differenza di altri suoi colleghi non fa corsi di scrittura ma corsi di lettura dei centri di salute mentale. «Lo faccio per offrire, a chi soffre un disagio psichico, parole che lo aiutino a leggere meglio dentro se stesso. L’uomo non si salva solo con la psichiatria, c’è bisogno di parole che arricchiscano l’uomo oltre la scienza. Ho bisogno di più parole per ragionare con me stesso, per entrare più in profondità dentro di me». Anche i giovani a scuola vanno aiutati a ritrovare parole. Lancia una provocazione: «Siamo sicuri che oggi, nel 2023, sia giusto insegnare la storia della letteratura per arrivare al massimo agli inizi del Novecento, o non sia invece più opportuno partire dall’oggi, e poi andare a ritroso?».
Il pubblico, genitori, insegnanti ed anche qualche studente, lo incalza. Vuole capire da dove nascono quei libri che costringono a guardare alla realtà, anche nei suoi aspetti più spiacevoli. «La realtà per me è l’approdo, è ciò che permette di salvarmi. A differenza di ciò che succede ad altri o a un certo luogo comune, la realtà per me non è il luogo della condanna ma è il luogo della salvezza. Da questo punto di vista, l’ospedale pediatrico Bambin Gesù è stato per me una formidabile scuola di scrittura. Quei bambini, che oggi c’erano e domani probabilmente non più, mi hanno provocato una rivoluzione nello sguardo. È come se mi avessero dato una lingua nuova, diversa, per parlare agli altri».
Si torna a parlare del tema del romanzo, l’autismo, della solitudine in cui si ritrovano i famigliari dei malati, dei servizi che mancano, di un’Italia, dove specialmente al centro e al sud, mancano anche i più elementari servizi. «Penso sia ormai inutile contare sulla politica centrale – avverte Mencarelli – forse si può costruire qualcosa solo partendo dal basso, da esperienze locali ricche di risorse».
Il padre protagonista del romanzo è sopraffatto da questi problemi, non ha nessuno su cui contare, dunque non c’è speranza? «La speranza – ecco il secondo avvertimento - non può diventare un’ideologia. Non possiamo chiedere ai genitori di essere degli eroi. C’è speranza quando queste solitudini vengono supportate da una rete, da una comunità. Ricordiamoci poi che gli esseri umani vivono la contraddizione fra ciò che dicono e ciò che pensano. Pietro dice cose terribili sul figlio ma non gli ha mai fatto mancare niente, neppure per un attimo. Pietro non è disperato, è disamorato. Nel mondo di oggi c’è molta ostilità verso la compassione. Tutti dicono “non voglio essere compatito”. No, io voglio la compassione. Perché non si dovrebbe patire insieme. I tre personaggi del romanzo che si accostano a Pietro e a suo figlio - Oliviero, Agata, Gaia - vivono un moto di autentica compassione nei confronti del ragazzo ed anche del padre».
A leggere il romanzo – chiediamo a Mencarelli – sembra sia stato scritto pensando a una serie televisiva, ritmo incalzante, cambio di scena…. «Il mio – risponde – è un tipo di scrittura che coglie l’uomo in azione, come gesto della realtà. Mi dicono che assomiglia al linguaggio cinematografico, ma non ho scritto pensando alla serie».
A quale prossimo progetto sta lavorando? «Scriverò, ma solo a partire dal 2024, un romanzo il cui tema di fondo è il rapporto della persona con la propria origine. Non solo l’origine famigliare, ma anche il quartiere, certi rapporti…».
Valerio Lessi
[Interviste] Fiammetta Borsellino, per una giustizia che ricrea
Poco prima del commiato dalla città di Rimini, durante il pranzo finale con gli organizzatori, abbiamo intervistato Fiammetta Borsellino, protagonista, insieme a don Claudio Burgio e al dott. Roberto Di Bella, di due incontri decisamente toccanti il 26 e il 27 aprile.
Fiammetta, i due incontri qui a Rimini, tra i tanti in cui sei protagonista in tutta Italia, cosa ti hanno lasciato?
Per prima cosa ho trovato una comunità che vive un percorso molto intenso di vita. Lo dico per come sono stati preparati gli incontri ma anche per le esperienze sul territorio che ho avuto modo di conoscere, esperienze virtuose. E' questo sicuramente il segreto dell’altissima partecipazione ed anche del livello degli interventi e delle domande durante i due incontri. Poi va detto che l’incontro con gli adulti ha permesso una riflessione più tecnica, sul tema della pena e del carcere, mentre con i ragazzi mi ha colpito la vivezza e la profondità delle domande, che volgevano più sugli aspetti umani implicati dal sacrificio di uomini come mio padre.
Eri insieme a don Claudio Burgio e al magistrato Roberto Di Bella. Mi pare ci sia stata una bella sintonia con gli altri relatori.
Sì. La magia di questi incontri è che a volte, pur non conoscendosi di persona ma perseguendo obiettivi comuni, quando ci si incontra è come se ci si conoscesse da sempre. C’è quell’essere veramente coordinati nel discorso che può sembrare preparato, ma non lo è. Nasce spontaneo, quando si va nella stessa direzione.
Fiammetta, la tua vicenda è stata al centro della storia italiana e ancora presenta dal punto di vista giudiziario molte macchie, molti vuoti. La tua battaglia per una ricerca della verità, cosa ha da dire oggi, per le vicende odierne, per le problematiche del nostro paese?
Purtroppo ciò che ha caratterizzato la strage di via D’Amelio, dove mio padre ha perso la vita insieme alla scorta, è molto simile a tanti eventi che sono caratterizzati dalle stesse oscurità, ovvero dall’impossibilità di raggiungere la verità sui mandanti. È un po’ come una storia che si ripete e tanti mi dicono “è successo sempre”. Ebbene, io questa cosa non l’accetto. Proprio perché si ripete, dobbiamo riflettere sul perché questo paese ha la memoria corta e soffre di amnesie. Proprio per i tanti depistaggi accaduti, si dovrebbe essere più attenti, ricordare, insistere. Non possiamo rinunciare al diritto alla verità. Rassegnarsi, per me sarebbe una sconfitta, sarebbe far morire mio padre una seconda volta. Il tema della ricerca della verità è un diritto irrinunciabile, che ci appartiene e che non può essere sepolto né dalle difficoltà, né dal tempo che passa.
Molti tra i ragazzi, i quali peraltro hanno fatto tantissime domande (ben 94 prima dell’incontro ed altre 40 durante l’incontro, inviate agli organizzatori grazie ad un Qrcode), sentono una profonda sfiducia nei confronti della possibilità di “ripartire”, sia per quel che riguarda i carnefici, ma anche per se stessi. Si può cambiare? Gli assassini di suo padre potranno pentirsi?
Certi cambiamenti avvengono, e avvengono indipendente dalla propria omertà. Non si è pentiti solo se si collabora fattivamente. Io credo nel cambiamento anche senza collaborazione. Tante volte uno non ce la fa a collaborare perché ha paura, paura per i figli, per se stesso, oppure perché non si libera da certi schemi. Ma questo non vuol dire che non ci sia in atto un percorso interiore. Questo percorso l’ho percepito in uno sguardo, in una compostezza di atteggiamento, da piccoli dettagli che vanno colti. I ragazzi fanno fatica a crederci, perché certe situazioni vanno sperimentate. Per questo l’impegno nel volontariato, confrontandosi con situazioni difficili, di disagio, aiuta moltissimo. Si comprende che il proprio darsi agli altri, ai fragili ai deboli a chi ha sbagliato, incide, è importante, opera il cambiamento che tutti desideriamo. Ma bisogno capirlo sul campo, non a parole. Capisco la loro fatica, dunque, e li invito all’impegno lì dove sono, nelle città, nelle scuole.
Infine, con una battuta, cosa ti ha colpito di più durante i due incontri?
Conoscere Di Bella e don Claudio è stato importante. Ho intravisto in don Claudio un sacerdote e in Di Bella un giudice dotati di un valore umano che è la vera origine del successo delle loro opere. Ma è impagabile la sincerità dei ragazzi. Loro, in maniera semplice e diretta non chiedono altro se non conoscere, nel senso più vero del termine. Vogliono quella sincerità che poi ricevono e offrono in momenti come questi.
Emanuele Polverelli
[Letture] Il senso religioso. Presentato il libro di don Giussani con prefazione di Bergoglio
Parlando con un gruppo di studenti universitari, nel 1995, don Luigi Giussani diceva: «Se leggeste questo capitolo una volta al mese per tre anni, mi ringraziereste; capireste una infinità di altre cose, mentre la prima volta che lo leggete non potete capire niente». Il sacerdote fondatore di Comunione e Liberazione stava parlando del decimo capitolo de Il senso religioso, il suo libro più famoso ed anche originale, in cui compiutamente si esprime la sua visione antropologica. E un sacerdote riminese, don Giancarlo Ugolini, raccomandava ai suoi studenti del liceo classico Karis di impararlo a memoria. È il capitolo dove don Giussani conduce il lettore a capire che l’uomo non si fa da sé, ma dipende in ogni istante dall’iniziativa di un Altro; e che la religiosità scaturisce dal vivere intensamente il reale, lasciando che lo sguardo sia stupito e attirato dalla presenza del ‘dato’.
Bastano queste considerazioni per avvertire che dal 1957 ad oggi Il senso religioso, non è stampato, ampliato, ristampato (nell’edizione 2023 con la prefazione di Josè Mario Bergoglio) come possono essere rieditate la Critica della ragion pura di Kant o la Fenomenologia dello spirito di Hegel. Per questi illustri filosofi non succede che ad una nuova edizione delle loro opere si organizzi una presentazione in streaming con centinaia di città (e anche piccoli paesi) collegati in Italia e all’estero. Kant ed Hegel semplicemente appartengono alla storia del pensiero, mentre Il senso religioso di don Giussani appartiene al cammino e al presente (è anzi generativo di questo presente) di una comunità formata da quanti sono stati conquistati dal carisma del sacerdote che pensò di lasciare una brillante carriera accademica e dedicarsi a una presenza educativa fra gli studenti in seguito ad un viaggio in treno da Milano a Rimini.
Tuttavia, come osserva Bergoglio nella Prefazione, «Il senso religioso non è un libro a uso esclusivo di coloro che fanno parte del movimento; neppure è solo per i cristiani o per i credenti. È un libro per tutti gli uomini che prendono sul serio la propria umanità. Oso dire che oggi la questione che dobbiamo maggiormente affrontare non è tanto il problema di Dio l’esistenza di Dio, la conoscenza di Dio, ma il problema dell’uomo, la conoscenza dell’uomo e il trovare nell’uomo stesso l’impronta che Dio vi ha lasciato perché egli possa incontrarsi con Lui».
Ed ecco allora che anche a Rimini (Teatro Galli e Teatro degli Atti), così come a Riccione (Palazzo del Turismo), a Cattolica (Park Hotel) e a San Mauro Pascoli (Cooperativa Amigi di Gigi) martedì 2 maggio centinaia e centinaia di persone si sono raccolte ad ascoltare la presentazione del libro proposta da Javier Prades, rettore dell’Università San Damaso di Madrid. Non solo ciellini, ma tutti coloro che desiderano confrontarsi con questa proposta che è il primo volume del PerCorso (gli altri sono dedicati, il secondo, a Gesù Cristo e alla sua pretesa di verità e, il terzo, al fenomeno della Chiesa).
Può essere che a qualcuno possa sembrare eccessiva questa insistenza su un libro. E che sarà mai? Curioso anche il fatto che quanti oggi hanno sessanta, settanta o si avvicinano agli ottant’anni, si erano confrontati con il libro di Giussani già nel 1975 (quando era un opuscolo) o nel 1986, quando uscì da Jaca Book la prima edizione dove confluirono gli ampliamenti maturati nelle lezioni tenute all’Università Cattolica. Perché rileggerlo ancora oggi, per l’ennesima volta?
Occorre rilevare che anche Giussani aveva molta fiducia sugli effetti benefici del suo libro. Sempre nella conversazione con gli universitari citata all’inizio, si fa avanti un giovane che si dichiara ateo e nichilista. Il sacerdote lo sfida in questo modo: «Ha letto Il senso religioso? La sfido a farmi un'obiezione a quelle pagine; siccome abita a Milano, ci possiamo trovare e lei mi farà le sue obiezioni a quelle pagine; se ha una sola obiezione sostanziale cui io non sappia rispondere, allora io mi metterò a cercare le ragioni del nichilismo. Secondo: lei deve chiamare la sua posizione secondo la verità del suo comportamento e il suo comportamento è di uno che, senza volerlo, cerca. Senza volerlo, perché il suo sentimento è come estraneo, ma la sua mente non può perdere la sua natura, e la natura della mente è cercare, inquisire».
Questo è Il senso religioso: una esaltazione della capacità della ragione di comprendere la realtà secondo la totalità dei suoi fattori. Una ragione che si impegna fino in fondo nell’indagare sul significato ultimo delle cose, fino a riconosce che il proprio vertice è il riconoscimento del mistero.
Una ragione che non si concepisce come stanza chiusa ma come finestra spalancata sulla realtà, fondata sulla categoria della possibilità, aperta all’imprevista e sorprendente irruzione della grazia. Ecco perché è utile rileggerlo e assimilarlo. Ecco perché il pensiero de Il senso religioso è capace di sfidare il nichilismo, il carattere liquido della cultura post-moderna, e anche quella cosiddetta «cultura dell’autenticità» che il filosofo canadese Charles Taylor legge come ultimo frutto del processo di secolarizzazione, un umanesimo esclusivo nel quale l’uomo si concepisce autosufficiente e autoreferenziale, chiuso a un rapporto con il Mistero.
Abbiamo citato la “cultura dell’autenticità” di Taylor perché da essa parte il professor Javier Prades, che martedì sera presenterà Il senso religioso, in un saggio ospitato nel volume di studi dedicato al pensiero filosofico di Giussani, uscito in occasione del centenario del sacerdote ambrosiano. Prades sostiene che la proposta globale di don Giussani è tale da sfidare positivamente anche l’ultimo stadio della secolarizzazione.
Chi frequenta il Meeting avrà certamente nella memoria la stupenda lezione svolta nel 2021 sul tema del raduno, Il coraggio di dire io. Prades, che è anche membro della Commissione teologica internazionale, è uno dei sacerdoti spagnoli che nella seconda metà degli anni Ottanta si coinvolsero con l’esperienza di Comunione e Liberazione. È cofirmatario, insieme a Giussani e Stefano Alberto, del libro Generare tracce nella storia del mondo, che è il frutto maturo della riflessione sull’esperienza di CL negli anni Novanta, così come Tracce di esperienza cristiana lo era stato per Gioventù Studentesca nel 1960. «Durante la stesura del libro – ha dichiarato – ho visto nascere un pensiero proprio a partire dal reale colto nell’esperienza vissuta».
Valerio Lessi


![[Interviste] Matteo Fadda, nuovo responsabile generale della Papa Giovanni XXIII](/media/k2/items/cache/31f56245ea204255d49363e86c103283_Generic.jpg)



![[Poesia] “Nasco dal mare”, la voce di Rosita Copioli](/media/k2/items/cache/758130ba23cf83bca690097348ab028c_Generic.jpg)
![[Storie] In Opera, il lavoro come riscatto](/media/k2/items/cache/5d6e49bee6f0b228ba5acb696433f640_Generic.jpg)

![[Interviste] Fiammetta Borsellino, per una giustizia che ricrea](/media/k2/items/cache/458363141f0d1651b67a739a73a7fb20_Generic.jpg)
![[Letture] Il senso religioso. Presentato il libro di don Giussani con prefazione di Bergoglio](/media/k2/items/cache/1d4dd6d4a0eafdca06bc3f0031f3fab5_Generic.jpg)